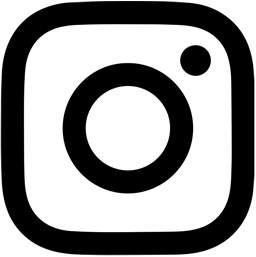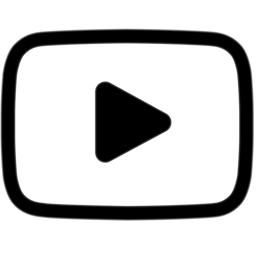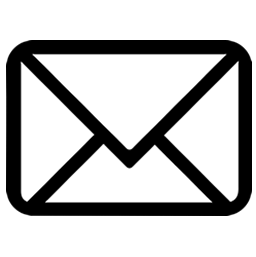di Saverio Pipitone
Ogni giorno indossiamo abiti scelti quasi senza pensarci, attratti da mode passeggere e offerte imperdibili. Dietro le cuciture perfette e i colori alla moda, però, si nasconde una rete complessa di storie, persone e luoghi che raramente emergono in superficie. Esistono filiere invisibili, processi oscuri e dinamiche che vanno ben oltre ciò che vediamo sugli scaffali o negli shop online. Guardare oltre l’apparenza diventa necessario per capire il sistema che ci veste ogni giorno. Ed è proprio questo sguardo critico e profondo che offre il saggio della giornalista investigativa Tansy Hoskins.
Ne “Il libro della moda anticapitalista” (ed. Il Saggiatore), di cui il sottotitolo è “Tra Karl Lagerfeld e Karl Marx” (uno stilista neoliberista vs pensatore comunista) – l’autrice spiega che “la moda è così intrecciata al capitalismo che non esisterebbe un’industria della moda senza lo sfruttamento capitalista del Sud del mondo, delle donne, del lavoro dei migranti, delle pratiche commerciali di un colonialismo razzista”.
Tansy Hoskins rivela cosa si nasconde dietro l’abbigliamento che portiamo: dai padroni della moda di massa al monopolio dei fashion media, con la manipolazione del consumatore per indurlo all’acquisto di innumerevoli capi di vestiario a basso costo, usa e getta, che sono fabbricati vessando lavoratori e natura.
Il libro della moda anticapitalista svela genocidi industriali, come quello del 24 aprile 2013 a Dhaka in Bangladesh con il crollo del Rana Plaza: fatiscente edificio multipiano, non a norma, dove c’erano cinque fabbriche tessili. Per costruirlo, fra materiali scadenti e sottili sottofondi, su un terreno paludoso riempito di sabbia e spazzatura, l’immobiliarista proprietario Sohel Rana aveva corrotto politici e funzionari pubblici. I pilastri cedettero per il sovraccarico dei macchinari, delle merci e degli operai, fino a cinquemila, che producevano per marchi occidentali – tra cui H&M e Zara: vi furono 1.133 morti e 2.438 feriti.
Un anno dopo il disastro, il magazine The Guardian pubblicò il web-documentario interattivo “The shirt on your back” con la testimonianza della superstite Mahmuda. Quel giorno, lei e suo marito Habibullah, entrambi ventenni, lavoravano al Rana Plaza e lui morì, lasciando orfana la neonata figlia Sumaiya: «Mio marito ha potuto vedere nostra figlia solo per 47 giorni. In un solo giorno è cambiato tutto. Ha mangiato ed è uscito di casa, come faceva ogni giorno, ma non è mai tornato. Il padre di mia figlia non tornerà mai a casa. Mia figlia mi chiederà: “Mamma, dov’è mio padre?” Cosa le dirò?».
Il Bangladesh e altri Paesi del Sud, dall’Asia e Africa all’America Latina, sono stati nell’ultimo ventennio colonizzati economicamente dal Nord globale a capitalismo suprematista, con lo sfruttamento della manodopera e delle risorse naturali, in uno scambio economico diseguale e nell’indifferenza delle conseguenze ambientali, umanitarie e sociali. In Bangladesh la forza lavoro nel tessile è quintuplicata, ma sprecata e schiavizzata, costretta per necessità a 14 ore di turno al giorno con una miserabile paga mensile di 80 euro, fabbricando a ritmo forsennato per la società consumista che – come sosteneva Zygmunt Bauman – si fonda sulla permanente insoddisfazione di bisogni e desideri. Vent’anni fa le collezioni H&M e Zara erano 2-3 l’anno, adesso sono 15-20, con il raddoppio degli acquisti a prezzi stracciati: una T-shirt costa appena 5 euro, indossata poche volte o mai, poi viene buttata. Per H&M e Zara, che dominano il fast fashion, dal 2002 al 2023 il fatturato è impennato da 3-4 miliardi a oltre 20 miliardi di euro, con profitti milionari intascati dai rispettivi proprietari Stefan Persson e Amancio Ortega, fra i più ricchi al mondo.
Sul mercato europeo del fashion – il secondo più grande dopo quello statunitense – il consumo medio annuo di vestiti, calzature e tessuti per la casa è di circa 15 chili pro capite, per una produzione complessiva che corrisponde allo sfruttamento di 175 milioni di tonnellate di materie naturali primarie, 180.000 km² di terreno, 20 miliardi di m³ di acqua verde e 4 miliardi di m³ di acqua blu, con emissioni di gas a effetto serra per 121 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, ma il 70-90% di questi impatti avviene al di fuori dell’Europa: nel Sud del mondo.
In Amazzonia, nel Cerrado, le aziende agricole che coltivano cotone estraggono al giorno 2 miliardi di litri di acqua, prosciugando fiumi o sorgenti, e vengono spruzzati ogni anno 600 milioni di litri di pesticidi distruggendo la biodiversità: un indiscriminato furto e deforestamento delle terre autoctone. Un’indagine del centro investigativo Earthsight ha scoperto che i fornitori di H&M e Zara acquistano il cotone in quella zona, in particolare da SLC Agrícola della famiglia nativa tedesca Logemann e dal gruppo Horita dell’omonima famiglia di origine giapponese, che sono fra i più grandi proprietari terrieri in Brasile.
Nel Bangladesh, a Dhaka, nelle aree vicine alle fabbriche tessili le acque superficiali e di rubinetto sono inquinate dai PFAS, ovvero sostanze chimiche usate per la produzione e chiamate eterne per la loro persistenza tossica, con effetti cancerogeni sugli esseri viventi.
In Ghana, ad Accra, nelle discariche informali ci sono montagne di vestiti scartati – tantissimi H&M e Zara – che contengono quasi sempre fibre sintetiche, acrilico o poliestere, a base di combustibili fossili, e decomponendosi rilasciano elementi chimici nocivi, come le microplastiche che contaminano l’aria, la vegetazione e il corpo umano dal cervello ai testicoli.
“Al momento – scrive Tansy Hoskins – l’obiettivo dell’industria della moda è riversare miliardi nelle tasche di chi è già ricco da far schifo e a mantenere assoggettati tutti gli altri, e il Sud del mondo in particolare; fare a pezzi la terra, avvelenare le acque, sfruttare gli animali e trattare i lavoratori da schiavi”.
Lo scorso agosto a Vienna sono stato al museo MAK per la mostra “Critical Consumption” ed era esposto il Manifesto per una rivoluzione della moda, stilato da un movimento globale di cittadini, per reclamare lavoro etico e dignitoso, retribuzione equa, diritti e solidarietà, artigianato e creatività, inclusività e diversità, conservazione ambientale, economia circolare, filiera trasparente, valore umano, libertà e celebrazione della vita. Chiunque può firmarlo su www.fashionrevolution.org/manifesto.
Per una moda rivoluzionata, di slow fashion, Tansy Hoskins immagina una società futura postcapitalista, fra decrescita, decolonizzazione e comunità di produttori associati, vestita diversamente senza classi, razze e generi, con un’industria piccola e lenta, localizzata ed ecologica.
Vale la pena citare un altro libro, cioè “Il giorno in cui il mondo smette di comprare” del giornalista indipendente JB MacKinnon che propone un’economia del deconsumo fondata sulla qualità piuttosto che sulla quantità, con prodotti fabbricati meglio e progettati per durare a lungo: “L’evidenza suggerisce – scrive MacKinnon – che la vita in una società a basso consumo può davvero essere migliore, con meno stress, meno lavoro o un lavoro più significativo e con più tempo per le persone e le cose che contano di più. […] tutto inizierebbe a cambiare, dai nostri desideri al ruolo dell’economia al futuro del clima del pianeta. Potrebbe essere la fine del mondo come lo conosciamo. Ma non sarà la fine del mondo”.