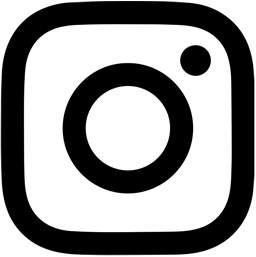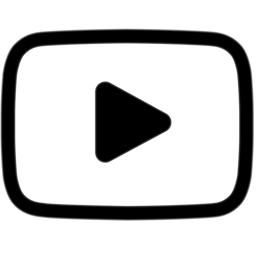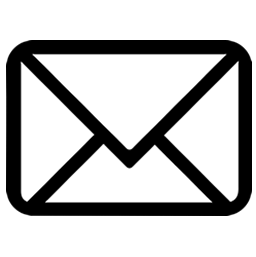Negli ultimi anni, la preposizione “senza” ha proliferato sulle etichette e nel linguaggio del marketing: “senza olio di palma”, “senza zucchero”, “senza solfati”, “senza solfiti” e così via, al punto che ci si è chiesti se un prodotto potesse essere venduto senza enfatizzare ciò che non contenesse.
Certamente, questa dichiarazione di “senza” poteva essere convertita in un valore aggiunto, con i prodotti “senza” che avevano un prezzo più elevato. Questo è giustificato dai nuovi modi di produzione più etici, meno produttivistici, ma anche dalla promessa di una buona salute. Una salute intesa in negativo, poiché ciò che viene venduto con il “senza” è piuttosto la garanzia dell’assenza di sostanze tossiche.
Così, dopo un periodo di abbondanza ed eccessi, i cui eccessi di ogni genere hanno portato contemporaneamente a problemi di salute e all’accelerazione del riscaldamento globale, la pubblicità promuove una società in cui la scarsità si diffonde a un ritmo che imita proprio quello dell’abbondanza. Abbondanza dell’assenza e della mancanza, rapidamente convertite in più e in pieno: la società di mercato ha ancora una volta vinto.
Il capitalismo, come la società dello spettacolo di Guy Debord, è riuscito a recuperare la mancanza nel flusso dell’abbondanza, a tradurre il meno in più, l’assenza in valore aggiunto, e, ciliegina sulla torta, vende etica a chi può permetterselo, poiché non tutti possono consumare il “senza”. Ciò non impedisce a tutti di continuare a consumare.
Sia che si sia orientati all’etica o che si sia poveri (l’opposizione imposta dal mercato), è necessario continuare a consumare: ma, sottolineando l’ultima sfumatura, se si consuma prodotti senza alcool e senza zucchero, non è forse la garanzia e l’espressione di una forma di ascetismo, in altre parole, di un modo di non consumare? Il marketing ha quindi inventato il consumo della non-consumazione. Un gioco di prestigio sublime che rischia di schiacciare tutti i progetti di decrescita lungo il suo cammino[…].
Ma torniamo un po’ indietro. La retorica del “senza” allude alla questione della mancanza. La logica capitalistica ha avuto l’intelligenza di assegnare al concetto di mancanza il ruolo di motore, spostando il concetto di mancanza dell’essere – che si riferisce al nostro status ontologico – verso la mancanza dell’avere. Come afferma Hannah Arendt, “lavoro e consumo sono solo due fasi del ciclo perpetuo della vita biologica. Questo ciclo ha bisogno di essere alimentato dal consumo, e l’attività che fornisce i mezzi per il consumo è l’attività lavorativa”, senza motivo per uscire dal ciclo che si rigenera da solo. I nostri bisogni generano mancanza, il consumo li soddisfa e richiede lavoro per rinnovarli, il quale aumenta i bisogni e così via.
Ma cosa c’è di più divertente della proposta capitalista di un consumo senza fine? Quella mancanza ontologica che costituisce la nostra condizione trova nella mancanza di oggetti un viatico, un’uscita di sicurezza. E non si tratta più solo di colmare la mancanza biologica, ma proprio della mancanza simbolica la cui espressione è l’angoscia: “La spiritualità potrebbe essere forse un dono di nascita del bambino, ma è stata confiscata dai mercati del consumo e poi riconvertita per lubrificare gli ingranaggi dell’economia di consumo”, scrive Zygmunt Bauman in “La società liquida”. Il problema è che questa vita liquida trasforma la natura delle cose: “La vita liquida è una vita di consumo. Tratta il mondo e tutti i suoi frammenti animati e inanimati come oggetti di consumo: cioè oggetti che perdono la loro utilità (e quindi il loro valore) mentre li si usa. Plasma il giudizio e la valutazione di tutti i frammenti animati e inanimati del mondo seguendo il modello degli oggetti di consumo.”
Estratto dell’analisi di Prof. di Filosofia presso l’Institut d’études politiques de Bordeaux, pubblicata su The Conversation