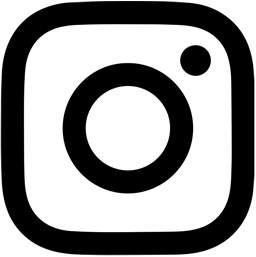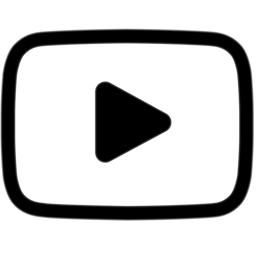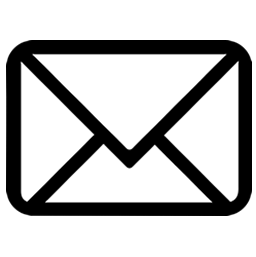Immaginatevi per un attimo: siamo nel 2009. Il mondo – o meglio, i leader del mondo sviluppato – si siede a un tavolo e decide che le nazioni più povere, quelle che già allora sentivano sulla pelle il bruciore del cambiamento climatico, dovessero essere aiutate. Viene stabilita una cifra quasi miracolosa: 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020. 100 miliardi di dollari per salvare chi soffre, per arginare l’ondata di disastri che incombe su di loro. Ma non basta pronunciare le cifre, bisogna mantenerle.
Da allora, sono passati 15 anni. Le temperature globali sono aumentate. Le emissioni di gas serra sono esplose. E quei 100 miliardi? Nel 2020 la cifra effettiva raccolta era di soli 83,3 miliardi. Non proprio quel grande gesto di solidarietà che ci avevano promesso.
Oggi, al vertice ONU sul clima, la COP29 a Baku, i grandi della Terra si ritrovano di nuovo per parlare di soldi, per stabilire nuovi impegni. E la domanda è sempre la stessa: quanto dovremmo donare per evitare il disastro? Chi dovrebbe mettere mano al portafoglio? E come verranno spesi questi soldi?
Questi fondi, che teoricamente dovrebbero salvare le nazioni più povere, rientrano in tre categorie. Primo, c’è il fondo per perdite e danni, una specie di cerotto sulle ferite già aperte: soldi per aiutare i Paesi che stanno già subendo le catastrofi climatiche. Ecco un esempio: negli ultimi 12 mesi, il Myanmar è stato colpito da inondazioni devastanti, mentre l’Africa orientale è stata attanagliata da una siccità senza fine. Eppure, c’è voluto un tempo infinito per far nascere questo fondo, perché le nazioni sviluppate non volevano accettare una verità amara: le loro azioni storiche hanno contribuito a creare questo caos climatico.
Poi c’è il tema dell’adattamento al cambiamento climatico. Immaginate una nazione che si prepara al peggio, costruendo dighe, case resistenti alle tempeste, spostando intere popolazioni dalle aree a rischio. È denaro investito nel futuro, non nel presente, ed è cruciale. Ma c’è un problema: storicamente, solo un terzo dei fondi è andato a questo scopo. Gran parte del denaro è stato destinato alla mitigazione, ovvero per aiutare i Paesi a smettere di inquinare. Anche qui, c’è un paradosso: i finanziamenti spesso vanno a sostenere progetti “redditizi”, come le centrali solari, perché sì, anche nel disastro climatico c’è chi fa affari.
E ora, entriamo nel cuore del problema: i soldi non bastano. Le stime variano, ma un recente studio parla di danni che potrebbero toccare i 580 miliardi di dollari entro il 2030. Un altro studio parla di 400 miliardi. Insomma, siamo di fronte a una catastrofe economica oltre che climatica. E mentre le cifre si moltiplicano, i fondi restano ridicoli in confronto alla portata della crisi.
C’è poi la grande domanda: chi pagherà davvero? Trent’anni fa, la risposta sembrava chiara: le nazioni sviluppate, che hanno inquinato di più e che hanno tratto enormi benefici economici dai combustibili fossili. Ma da allora, lo scenario è cambiato. La Cina, una volta vista come “nazione in via di sviluppo”, oggi è una potenza economica con un’impronta di carbonio impressionante. E gli Stati Uniti – non proprio conosciuti per la loro generosità in campo ambientale – vorrebbero che la Cina contribuisse obbligatoriamente, non solo volontariamente.
E nel frattempo? Mentre i potenti discutono su chi deve pagare cosa, il clima non aspetta. Continua a cambiare. Le tempeste continuano a colpire, i fiumi continuano a straripare, e milioni di persone continuano a soffrire. Forse, invece di concentrarci su quanti trilioni di dollari siano necessari, dovremmo chiederci: quando inizieremo ad affrontare il cambiamento climatico con l’urgenza che merita?