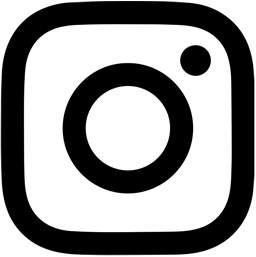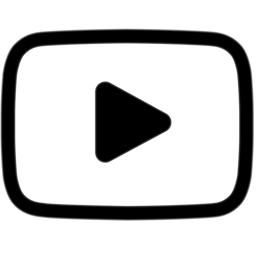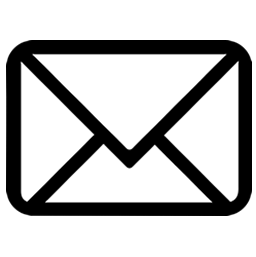Il welfare? A Singapore è una sorta di “parolaccia”. Questo, almeno, è ciò che ha dichiarato un giorno con fierezza l’ex primo ministro Lee Hsien Loong. L’idea di fondo è che la città-stato non apprezza la carità, ma esalta l’autosufficienza. Niente pensioni pubbliche per i lavoratori: ognuno deve versare contributi sui propri conti pensionistici individuali. Anche l’assistenza sanitaria non è un diritto acquisito, ma va pagata con risparmi obbligatori, lontano dalle politiche assistenziali a cui siamo abituati. Non esistono nemmeno salari minimi o sussidi per beni essenziali come riso o elettricità.
Curiosamente, però, c’è un’area dove il governo interviene eccome: mangiare fuori. In un mondo in cui la maggior parte dei governi lascia che sia il mercato a regolare l’offerta gastronomica, Singapore fa esattamente il contrario.
In tutta l’isola ci sono 121 “centri ambulanti” gestiti dal governo, con oltre 6.000 piccole bancarelle private. Queste food court non sono un residuo del passato: negli ultimi nove anni ne sono state costruite altre 14, con l’ultima inaugurata di recente. Il governo controlla tutto: dal tipo di cibo venduto (deve esserci un mix di cucine diverse, con opzioni halal per i musulmani locali), ai prezzi (alcuni devono offrire almeno un piatto a circa 3,50 dollari di Singapore), fino a chi può cucinare (solo singaporiani e residenti permanenti).
Ovviamente, come da copione, le regole per i clienti non mancano. Recentemente è stata introdotta una legge che obbliga a ripulire i tavoli dopo aver mangiato, pena una multa di 300 dollari di Singapore. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il tasso di restituzione dei vassoi è bloccato al 90%, generando non poca frustrazione tra i politici.
Ma perché tutto questo impegno statale sui centri ambulanti? Originariamente, negli anni ’60 e ’70, furono creati per togliere i venditori di cibo dalle strade e migliorare ordine e igiene pubblica. Oggi sono visti come una sorta di “mensa comunitaria”, dove i cittadini possono mangiare bene senza spendere troppo. Il governo li considera anche come un simbolo di armonia etnica: cuochi e clienti di diverse razze e religioni condividono spazi e pietanze in maniera pacifica. Nel 2020, l’UNESCO ha persino aggiunto la “cultura dei venditori ambulanti” di Singapore al patrimonio mondiale, su richiesta del governo. Tuttavia, questa integrazione sociale ha i suoi limiti: vedere gruppi misti a un tavolo è raro.
Nonostante tutto, il governo sembra deciso a mantenere vivi questi centri, anche se le difficoltà non mancano. I venditori ambulanti lavorano ore interminabili in condizioni difficili, e l’età media di chi lavora in queste bancarelle si aggira intorno ai 60 anni. Il rapido sviluppo economico di Singapore ha portato il reddito medio a oltre 48.000 dollari l’anno, ben sopra paesi come la Germania o il Giappone. C’è quindi il timore che i giovani non siano più interessati a questo mestiere, e che la tradizione dei venditori ambulanti scompaia lentamente senza un intervento.
Per contrastare questa tendenza, il governo ha lanciato una serie di iniziative. Tra queste, il “Programma di stallo di incubazione”, che offre affitti ridotti per bancarelle completamente attrezzate per 15 mesi, così che i nuovi arrivati possano avviare l’attività senza troppi rischi economici. C’è poi il “Programma di successione”, che mette in contatto i venditori veterani con aspiranti nuovi arrivati, affinché le bancarelle possano sopravvivere anche dopo il pensionamento del proprietario. Per agevolare il lavoro, esistono anche sovvenzioni che coprono fino all’80% dei costi di nuove attrezzature.
Il programma più ambizioso, però, è il “Programma di sviluppo dei venditori ambulanti”, che offre corsi di formazione, apprendistati e tutoraggio. In un corso di cinque giorni, per esempio, si insegnano non solo i segreti del mestiere, ma anche come gestire un’impresa. Il Programma è attivo dal 2020, e su 566 aspiranti venditori, solo 120 hanno completato l’apprendistato. Ancora meno, 29, hanno avviato una bancarella, e solo 16 continuano a operare.
In altre circostanze, il governo di Singapore, solitamente molto pragmatico, avrebbe già abbandonato un piano con un tasso di successo così basso. Eppure, sui centri ambulanti sembra esitare: li vuole preservare, ma senza proteggere eccessivamente chi ci lavora. Nonostante creda molto nel mercato libero, il governo non vuole che gli 8.000 punti vendita privati e i numerosi ristoranti eliminino la necessità dei centri statali.
In un recente discorso, l’attuale primo ministro Lawrence Wong ha paragonato Singapore a un piatto di riso al curry hainanese: un mix di influenze occidentali, cinesi, malesi e indiane. “Un piatto così unico“, ha detto, “si può trovare solo in una società inclusiva e multiculturale come la nostra”. Poco importa se la minoranza musulmana non si riconosce in un piatto a base di carne di maiale, o se il riso al curry hainanese è talmente sconosciuto che il principale giornale locale ha dovuto pubblicare un articolo per spiegarlo. A quanto pare, ai politici di Singapore piacciono le metafore legate al cibo di strada ancora più del cibo stesso.