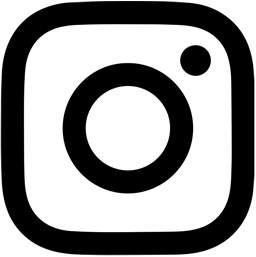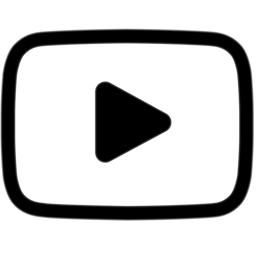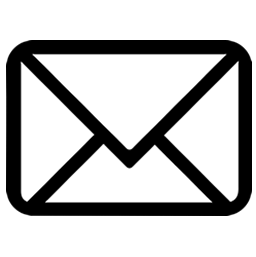Negli ultimi vent’anni la produzione globale di plastica è raddoppiata. Secondo le stime più accreditate, potrebbe raddoppiare ancora nel giro di pochi decenni. È un modello industriale preciso, costruito nel tempo e difeso con determinazione. È questo il cuore dell’intervista alla giornalista ambientale Beth Gardiner pubblicata dal The Guardian, in cui l’autrice presenta il suo libro Plastic Inc e racconta anni di ricerca sul legame tra industria fossile e materie plastiche.
Gardiner racconta di aver vissuto per anni come molti cittadini attenti all’ambiente: borse riutilizzabili, bottiglia d’acqua in metallo, attenzione agli imballaggi. La prospettiva è cambiata quando ha scoperto che le aziende dei combustibili fossili avevano investito oltre 180 miliardi di dollari in nuovi impianti petrolchimici negli Stati Uniti dal 2010. Dietro al problema dei rifiuti c’è la strategia di un’industria che, mentre il mondo parla di transizione energetica, investe massicciamente nella plastica.
La plastica deriva direttamente da petrolio e gaa; l’estrazione, il trasporto, la produzione e lo smaltimento generano emissioni climalteranti, secondo le Nazioni Unite, nel 2019 le plastiche hanno prodotto circa 1,8 miliardi di tonnellate di gas serra, pari a oltre il 3 per cento delle emissioni globali. Se la domanda di carburanti per il trasporto dovesse diminuire con la diffusione delle rinnovabili e dell’elettrico, la chimica della plastica è destinata a diventare uno dei principali motori della domanda di petrolio.
Nel corso della sua ricerca, Gardiner ha visitato Reserve, in Louisiana, lungo il Mississippi, in quella che viene chiamata “Cancer Alley”. Qui ha incontrato Robert Taylor, attivista che da anni denuncia i livelli elevati di sostanze tossiche provenienti dagli impianti petrolchimici vicini alle abitazioni. Quartieri a maggioranza afroamericana esposti a emissioni nocive, famiglie colpite da malattie oncologiche, comunità che pagano il prezzo della produzione globale di oggetti usa e getta. Quando parliamo di plastica, osserva Gardiner, pensiamo alla bottiglia o al sacchetto che teniamo in mano. Raramente pensiamo a chi vive accanto agli stabilimenti che li producono. In Indonesia ha camminato su una collina di rifiuti plastici provenienti dall’estero, tra imballaggi di marchi europei e statunitensi. Per anni i Paesi ricchi hanno esportato parte dei propri scarti verso l’Asia. Dal 2018, con il divieto imposto dalla Cina all’importazione di rifiuti, quel flusso si è spostato altrove, in un gioco globale opaco che coinvolge altri Paesi del Sud-Est asiatico. Il problema cambia geografia, resta invariato.
Un elemento centrale dell’inchiesta riguarda la costruzione culturale del modello usa e getta. Già negli anni Cinquanta e Sessanta, nelle conferenze dell’industria della plastica, si parlava apertamente del maggiore profitto garantito da prodotti destinati a essere buttati dopo un solo utilizzo. La plastica è stata promossa come soluzione comoda, igienica, moderna: un materiale economico, abbondante, versatile, diventato il materiale fondamentale del consumismo contemporaneo. Quando l’opinione pubblica ha iniziato a preoccuparsi per l’accumulo dei rifiuti, l’industria ha reagito con strategie comunicative efficaci. Negli Stati Uniti, alla fine degli anni Cinquanta, grandi aziende fondarono l’organizzazione Keep America Beautiful, presentata come iniziativa civica contro l’abbandono dei rifiuti. Il messaggio era semplice: il problema è chi getta la spazzatura per strada, la responsabilità ricade sul cittadino. L’attenzione si è così spostata dal volume di produzione alla gestione individuale dei rifiuti. Anche il riciclo ha avuto un ruolo importante in questa narrazione. Funziona bene per materiali come vetro, alluminio e carta; per la maggior parte delle plastiche è complesso, costoso, spesso inefficiente. La plastica perde qualità a ogni ciclo di lavorazione e finisce comunque in discarica o in incenerimento. L’idea che basti separare correttamente i rifiuti per risolvere il problema ha contribuito a ridurre la pressione sul sistema produttivo. Nel frattempo, microplastiche sono state rilevate negli oceani più profondi, sui ghiacciai, nell’aria, negli alimenti e nel corpo umano. Esiste una letteratura consolidata sugli effetti delle sostanze chimiche presenti nella plastica, associate ad alterazioni endocrine, problemi cardiovascolari e aumento del rischio oncologico.
Sul piano politico, l’industria dei combustibili fossili e quella delle materie plastiche, spesso coincidenti, esercitano una forte attività di lobbying. I negoziati internazionali per un trattato globale contro l’inquinamento da plastica hanno visto una presenza significativa di rappresentanti industriali. Negli Stati Uniti le prospettive di regolamentazione dipendono fortemente dal contesto politico federale, mentre in Europa l’Unione europea ha adottato alcune misure sulle plastiche monouso e sulle sostanze chimiche, con risultati ancora parziali. Secondo Gardiner, la differenza reale si gioca nelle leggi, negli standard produttivi, negli investimenti industriali, nella responsabilità estesa del produttore lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Le borse riutilizzabili e le bottiglie in metallo restano scelte sensate, ma da sole non bastano.
Un mondo con molta meno plastica è stato la norma fino a poche generazioni fa. Alcuni usi restano essenziali, in ambito medico o tecnologico. Molti altri sono il risultato di un modello economico che ha privilegiato l’usa e getta come moltiplicatore di profitti. Finché la plastica continuerà a rappresentare uno dei pilastri della redditività fossile, la transizione ecologica resterà incompleta.