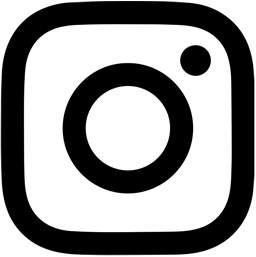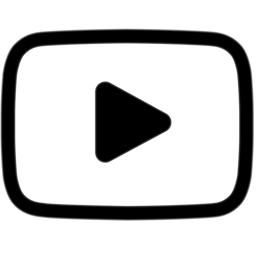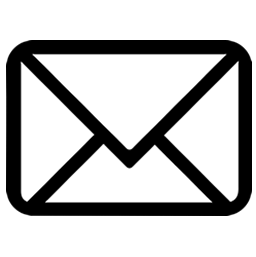di Dino Alberti – Se vogliamo mettere in atto una vera lotta all’inquinamento e contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti plastici, serve andare alla fonte del problema, ossia all’eccessiva produzione di rifiuti.
I dati CONAI dicono che nel 2018 sono stati immessi sul mercato poco più di 2,3 milioni di tonnellate di imballaggi plastici. Di questi, solo il 43% è stato avviato a riciclo, pari a circa un milione di tonnellate, in leggero aumento rispetto al 2017 ma comunque troppo poco. Infatti, oltre la metà degli imballaggi plastici che circolano in Italia prendono altre strade diverse dal riciclo, ovvero lo smaltimento legale ed illegale.
L’introduzione delle tasse di scopo sulla plastica non vanno a risolvere il problema della riduzione della plastica se non in minima parte. La tassa di scopo, infatti, mira a colpire un comportamento scorretto invogliando il consumatore a modificare le proprie abitudini, privilegiando prodotti privi di imballaggio. Ragionando per estremi, il fine ultimo dell’imposta ambientale è l’azzeramento del consumo di imballaggi e di conseguenza il gettito generato da essa dovrebbe tendere a zero. Se però la tassa viene imposta a copertura di altri provvedimenti, queste iniziative vengono meno nel momento in cui termina il comportamento non virtuoso perché cessa il gettito derivante e quindi la copertura. In sintesi, un cane che si morde la coda.
In secondo luogo, la tassa di scopo va a creare un effetto discriminatorio tra chi può permettersela e chi no. In altre parole, la sovrattassa provocherà effetti evidenti solo per quella fascia di popolazione meno abbiente per la quale anche un aumento minimo del prezzo dei beni di consumo comporterà un pesante effetto sulle loro tasche. Si arriverà a penalizzare i consumi dei più deboli, a ridurre gli introiti delle aziende e non si arriverà a generare nessun cambiamento reale né dei consumi né delle produzioni.
Per i più ricchi, invece, cambierà poco o niente. Come esempio, vale lo stesso discorso che si applica per l’aumento dell’IVA. Un aumento dell’imposta sul consumo, sia essa sul valore aggiunto sia essa ambientale, per i più abbienti risulta essere irrilevante tanto da non modificare le loro abitudini e stili di vita. Continueranno a pagare, senza difficoltà, le maggiorazioni stabilite.
Il problema dell’eccessiva produzione di plastica va invece risolto alla radice adottando un diverso approccio pratico che punti ad eliminare il problema alla fonte. In Germania lo fanno dagli anni ’90, da quando cioè hanno introdotto il vuoto a rendere su tutte le bottiglie di plastica, vetro o latta. Le bottiglie di bevande, birra, vino e acque minerali, una volta consumato il loro contenuto, devono essere restituite dai clienti ad un qualsiasi esercizio commerciale. Questo è tenuto ad accettare il vuoto e contestualmente a restituire al consumatore una cauzione precedentemente versata al momento dell’acquisto. E’ a carico dell’esercente l’onere dello stoccaggio e della restituzione ai propri fornitori dei vuoti che invece di essere inviati al riciclo vengono mandati a impianti di lavaggio per il loro riutilizzo.
Le cosiddette “bottiglie a rendere”, si riconoscono per gli inevitabili segni dovuti ai ripetuti passaggi negli impianti di lavaggio ma soprattutto dalla plastica più rigida e consistente con cui sono fatte. Difficilmente si riesce a schiacciare una “bottiglia a rendere” proprio perché non sono state progettate per essere “usa e getta” ma per essere un vero e proprio bene durevole. La loro consistenza fa sì che possano essere riutilizzate per almeno 20 cicli di lavaggio prima del loro definitivo riciclo. Ciò comporta un notevole abbattimento dei consumi e della quantità di rifiuti prodotti, e quindi meno inquinamento e possibilità di lucro per la criminalità organizzata.
Il vuoto a rendere deve essere fatto con i giusti tempi facendo in modo che i produttori di imballaggi possano esaurire le scorte di lavorati e semilavorati in magazzino, riconvertendo gli impianti per la produzione di “bottiglie durevoli”.
In Germania tutti questi processi vengono svolti da decenni senza che nessuno ne abbia mai fatto una tragedia e grazie a questa misura il 97% delle “bottiglie a rendere” viene recuperato.
Il riuso è quasi sempre preferibile al riciclo il quale è, a sua volta, più opportuno rispetto al recupero energetico che distrugge definitivamente la materia dissipando per sempre il suo potenziale. E il riuso ha un bilancio energetico nettamente migliore rispetto al riciclo dato che nel primo caso i materiali di post consumo vengono riutilizzati per le medesime finalità senza subire ulteriori processi di lavorazione.
Ridurre alla fonte il rifiuto porterebbe ad un altro importante miglioramento nella sicurezza pubblica e ambientale, eliminando una grossa fonte di guadagno per la criminalità organizzata. Si ridurrebbe infatti in maniera drastica il mercato illegale di smaltimento e dei traffici illeciti e di tutti quegli episodi di incendi di impianti di trattamento e stoccaggio a cui si assiste con sempre più frequenza.
Per contrastare questo fenomeno, però, è necessario modificare anche il processo burocratico-amministrativo del sistema gestito dal Conai che oggi regge la filiera della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
In Italia, all’atto dell’immissione dei prodotti di consumo sul mercato, chi produce o importa paga il contributo ambientale Conai o CAC allo stesso consorzio. Il produttore, per recuperare il contributo versato, applica un sovrapprezzo al suo prodotto. A sua volta il Conai usa il CAC per coprire i maggiori costi derivanti dalla raccolta differenziata sostenuti dai Comuni.
Oltre al CAC, il Conai, attraverso i suoi associati come ad esempio COREPLA per la plastica, ottiene un guadagno all’atto della vendita delle materie prime seconde vendute ai riciclatori, andando ad incrementare il bilancio del consorzio. Un meccanismo che a parole sembra impeccabile ma che all’atto pratico ha delle falle che sono state denunciate diverse volte nel corso degli anni.
Come ad esempio nel 2015, in seguito ad un’indagine dell’Antitrust che accertò che solo il 20% del totale dei costi della differenziata sostenuto dai Comuni veniva coperto del CONAI, laddove invece, avrebbe dovuto essere per intero a carico suo. Per quell’anno il CONAI incassò complessivamente 593 milioni di euro (368 milioni dal CAC) ma ne versò solamente 437 a fronte di un costo complessivo sostenuto dai comuni di oltre 2 miliardi. La situazione temiamo non sia di certo migliorata se non gli incassi del CONAI che nel 2018 registrava, per il solo CAC, 572 milioni di euro +12% sul 2017.
Una situazione totalmente differente rispetto a quella di altri Paesi europei. In Germania e in Austria i costi di raccolta degli imballaggi domestici sono a carico esclusivamente di chi produce e commercializza imballaggi mentre in Francia si raggiunge il 75% di copertura da parte dell’omologa agenzia.
La proposta più logica sarebbe quella di modificare il sistema partendo dal CAC. L’intero onere di spesa deve essere a carico dei produttori e, al tempo stesso, all’interno del nuovo CAC deve essere contemplata anche una quota assicurativa che garantisca la copertura dei maggiori costi conseguenti alla mancata vendita dei materiali derivanti da RD e post selezione. Questo passaggio è indispensabile per dissuadere taluni imprenditori del settore del trattamento rifiuti dall’affidarsi alla criminalità organizzata per smaltire in modo rapido e illegale grandi quantità di immondizia. Spesso a bruciare nei capannoni del nord e di tutta Italia sono materie prime seconde che non trovano più una collocazione sul mercato, diventando quindi un costo per l’impresa e non più una risorsa. Il CAC dovrebbe anche coprire questi oneri indiretti della Raccolta Differenziata affinché non vi siano più alibi per chi continua ad operare nell’illegalità.