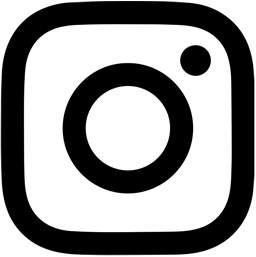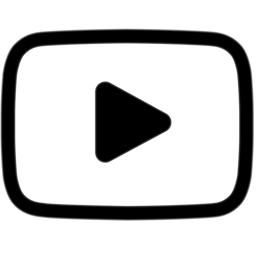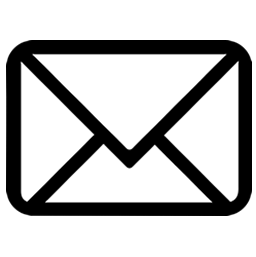di Tim Jackson – Il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz ha recentemente sottolineato che c’è qualcosa di «fondamentalmente sbagliato» nel modo in cui misuriamo il progresso economico e sociale.
Convenzionalmente misuriamo il successo economico di una nazione con il Pil, cioè considerando il valore economico di beni e servizi prodotti nell’economia. Ma il Pil nulla dice sulla distribuzione del reddito tra ricchi e poveri, sui costi ambientali di produzione e del consumo, e dice poco anche sulla capacità di miglioramento del nostro benessere sul lungo periodo. Cibo spazzatura, droghe, sigarette, traffico, incidenti stradali, accoltellamenti, alcolismo, dipendenza da gioco d’azzardo, fuoriuscite di petrolio, emissioni di carbonio: tutto questo può contribuire alla crescita del Pil, ma certo non favorisce il nostro benessere.
Gli economisti, persino i padri del Pil, sono consapevoli di questi limiti da decenni. In un rapporto al Congresso degli Stati Uniti sugli “Usi e abusi delle misurazioni del reddito nazionale” nel 1934, uno di quei padri – un altro premio Nobel – Simon Kuznets, sottolineò:«Il benessere di una nazione difficilmente può essere dedotto da una misura di reddito nazionale».
Tre decenni dopo, l’ex procuratore generale degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy, sintetizzò così i limiti del Pil: «Non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta».
Nel 2009 il governo francese ha pubblicato una critica sostanziale del Pil come indice della performance economica o del progresso sociale. Persino la rivista The Economist oggi riconosce che il Pil non può misurare la prosperità.
Nonostante questi avvertimenti, l’eccessiva dipendenza dal Pil ha impedito alla maggior parte di economisti e politici nel 2007/8 di vedere che un debito insostenibile ci stava conducendo a una crisi finanziaria globale. Allo stesso modo, ha impedito di capire che la “ripresa” sarebbe andata soprattutto a beneficio dei ricchi, portando a crescenti disuguaglianze e lasciando indietro intere comunità, e li ha inoltre resi ciechi ad alcune serie minacce per la sicurezza economica e la stabilità sociale sul lungo periodo, quali il cambiamento climatico e la perdita delle biodiversità.
Di solito, la soluzione politica a problemi urgenti quali povertà, debito e crisi climatica risponde al precetto di rafforzare la crescita del Pil e renderla più sostenibile o inclusiva.
I termini “crescita verde” e “crescita inclusiva” sono, infatti, sempre più comuni nei dibattiti. A volte, i commentatori sostengono che rendere la crescita più sostenibile o più inclusiva porterà di per sé una nuova era di crescita del Pil. Il successo della crescita verde si basa intrinsecamente sull’idea che possiamo “disaccoppiare” la produzione economica misurata con il Pil dai suoi impatti sull’ambiente. […]
Non che non sia necessario disaccoppiare il benessere dalla produzione materiale. Al contrario, è vitale farlo per poter offrire una ricchezza più sostenibile per le persone e per il pianeta. Ma vaghe aspirazioni non bastano a raggiungere gli obiettivi essenziali per salvare il clima o le biodiversità. Fondamentalmente, i principi economici di base sono cambiati negli ultimi decenni. Rinomati economisti parlano ormai apertamente di una “stagnazione secolare” che rallenta i tassi di crescita, in particolare nelle economie avanzate. Questo rallentamento non è una semplice conseguenza della crisi finanziaria. Dagli anni ’60 il tasso di crescita medio nell’OCSE si è più che dimezzato. Il “puzzle di produttività” che continua a perseguitare il Regno Unito, in particolare, è sintomatico di questo declino.
Questi dati rappresentano un serio dilemma per i governanti. Da un lato, nel nostro attuale modello economico, i posti di lavoro, i prezzi delle azioni, i rendimenti degli investimenti e le entrate fiscali dipendono dalla crescita economica.
Scegliendo la crescita del Pil come principale indicatore di successo, è probabile che finiremo per prendere le decisioni sbagliate. Se i nostri indici raccontano che tutto va bene quando non è così, diventeremo compiacenti, come affermato da Stiglitz: «Dovrebbe essere chiaro che, nonostante gli aumenti di PIL, nonostante la crisi del 2008 sia ben dietro le nostre spalle, non tutto va bene»
Abbiamo bisogno di identificare nuovi indici di misurazione più adatti a un benessere sostenibile. Negli ultimi decenni sono state molte le iniziative per sostituire, rivedere o integrare il Pil. Questi tentativi hanno considerato un ampio raggio di fattori: alcuni, tentando di valutare più fedelmente il benessere umano; altri, mirando a riflettere più accuratamente la situazione ambientale; altri ancora, cercando di catturare gli aspetti di lungo termine delle attività economiche con maggiore coerenza di oggi.
Tanto i limiti del PIL quanto lo sviluppo di alternative sono stati ampiamente studiati. In linea di massima, possiamo dividere le alternative individuate in quattro tipologie di indicatori di benessere:
- set di indicatori multipli (o dashboard);
- indici non monetari aggregati;
- indici monetari aggregati o rettificati; e
- misure di benessere soggettivo o “personale”.
Probabilmente, il più noto tra i “dashboard” è l’insieme di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), declinati in 169 sotto-obiettivi.
Un’altra iniziativa “dashboard” ampiamente discussa è il “Living Standards Framework” della Nuova Zelanda che incorpora 38 indicatori, suddivisi in 12 ambiti di benessere, tra cui il tema casa, l’identità sanitaria e culturale, nonché misure di impatto ambientale, approccio richiesto recentemente anche al G20.
Uno dei problemi dell’approccio dashboard è la necessità di valutare i compromessi tra i progressi in un indicatore e la mancanza di progressi in un altro.
Anche per superare questa difficoltà, si è provato a sviluppare degli indicatori aggregati non monetizzati, che combinano numerosi indicatori in un unico dato che, per eccesso, rifletta i progressi. Esempi di questo tipo di indice aggregato sono l’Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite e l’Indice di progresso sociale di Deloitte, entrambi basati in una certa misura sul lavoro dell’economista premio Nobel Amartya Sen.
Esempi di indicatori aggregati monetizzati includono l’indice di risparmio netto rettificato della Banca mondiale e il Genuine Progress Indicator (Gli), sviluppato inizialmente dall’economista ecologico Herman Daly e successivamente applicato in numerosi paesi in tutto il mondo. Uno dei vantaggi di indici monetari come il Gli è la possibilità di confrontarli direttamente con il Pil. Uno svantaggio, è che richiede la valutazione monetaria di ogni componente dell’indice, ma attribuire un valore monetario alla natura o ad alcuni aspetti della vita sociale è difficile e controverso.
Le misure di benessere personale mirano ad aggirare le carenze del Pil e i problemi associati all’aggregazione e alla valutazione monetaria. I sostenitori delle misure soggettive legate alla soddisfazione nella vita, alla felicità o all’appagamento, infatti, affermano che tali indici offrano una guida utile al benessere di una nazione e forniscano una misura più significativa del progresso sociale. Ancora una volta, i confronti tra tali misure e misure di reddito possono risultare complessi, perché come mostra la figura qui sotto, la relazione non è non lineare.
Riassumendo, i politici hanno a disposizione svariati indicatori alternativi del progresso sociale. Come il Pil, questi indicatori presentano diversi punti di forza e di debolezza. Alcuni sono migliori nel rappresentare informazioni statistiche dettagliate. Altri permettono di delineare chiaramente dati accessibili in merito ai progressi o alla loro mancanza.
La scelta degli indicatori giusti è fondamentale per orientare le scelte politiche; ma per raggiungere un’economia del benessere occorre andare oltre la questione della misurazione e iniziare a concepire un diverso tipo di economia.
Il concetto di “economia del benessere” riscuote sempre più interesse. In parole povere, con benessere intendiamo “come stiamo” in quanto individui, comunità e nazione. Nel Regno Unito, il Programma di Misurazione del Benessere Nazionale dell’Ufficio per le statistiche nazionali (ONS) ha identificato dieci aspetti di particolare importantanza per i cittadini britannici: l’ambiente, il benessere personale, le relazioni, la salute, ciò che facciamo, il luogo in cui viviamo, le finanze personali, economia, istruzione, competenze e amministrazione.
Nel suo ultimo bollettino sul benessere personale ed economico nel Regno Unito, l’ONS ha riportato un calo sia della soddisfazione della vita sia della sensazione che le cose fatte nella vita siano utili. I livelli di ansia nel Regno Unito sono “elevati”, circa 10,6 milioni di persone si dicono ansiose.
Chiaramente, queste statistiche sono utili per cogliere l’umore del Paese e il senso di progresso nella società, ma l’economia del benessere non è solo un programma di misurazione. Si fonda, piuttosto, sull’idea che l’obiettivo dei governanti dovrebbe essere la ricerca del benessere e non la crescita economica misurata dal Pil.
Il Gruppo Parlamentare Misto per l’Economia del Benessere ha sostenuto che il concetto di benessere funge da “inquadramento prezioso e pragmatico per prendere decisioni politiche e per impostare una visione per il Regno Unito”.
La Wellbeing Economy Alliance (WEAll) è una collaborazione globale di organizzazioni, alleanze, movimenti e individui che lavorano insieme per cambiare il sistema economico. WEAll mira a cambiare la narrazione popolari sullo scopo dell’economia e apromuovere un concetto di economia che offra benessere umano ed ecologico. Sulla base di tale approccio, nel 2018, Scozia, Islanda e Nuova Zelanda hanno creato l’iniziativa Governi per il benessere (WEGo) al fine di condividere idee su come migliorare la vita delle persone e il “successo dei nostri paesi”.
Lo scorso anno, durante la presidenza finlandese, il Consiglio dell’UE ha definito l’”economia del benessere“ come: «un approccio orientato alle politiche e alla governance che mira a mettere le persone e il loro benessere al centro delle politiche e del processo decisionale»
Secondo l’OCSE, l’“economia del benessere” è un’economia che:
- espande le opportunità di miglioramento della vita delle persone negli aspetti per loro più importanti;
- assicura che queste opportunità si traducano in risultati di benessere per tutti i segmenti della popolazione;
- riduce le disuguaglianze e garantisce la sostenibilità ambientale e sociale.
Chiaramente, il perseguimento di questi obiettivi dipende dall’avere indicatori appropriati, attraverso i quali misurare i progressi verso gli obiettivi desiderati. Ma l’esistenza di tali indicatori, da soli, non garantisce il successo nel realizzare un’economia del benessere: è necessario che tali indicatori influenzino concretamente le scelte politiche. In un recente position paper, il Gruppo Parlamentare Misto per l’Economia del Benessere ha pubblicato una “revisione della spesa per l’aumento del benessere” per illustrare come si potrebbe governare con un’ottica diversa, traendo ispirazione da un’azione simile in Nuova Zelanda.
Nel 2019, il Ministero del Tesoro neozelandese ha pubblicato il primo bilancio per il benessere, in cui le allocazioni di spesa sono state definite sulla base di quei Living Standards Framework di cui alla sezione precedente. In questo caso, poiché il Living Standards Framework è stato sviluppato in seno al Ministero del Tesoro neozelandese.Il successo dell’operazione è stata garantita da un impatto diretto sul processo decisionale di spesa.
Possiamo dire che il nocciolo dell’approccio volto a un’economia del benessere risiede nell’allineare al massimo la politica di governo con l’obiettivo di raggiungere il benessere della società, invece della sterile ricerca di crescita del Pil. Per questo serve che la politica guardi non solo ai ben noti “aggregati” macroeconomici di produzione, reddito, investimenti e così via, ma anche alla distribuzione di tali variabili nella società, al loro impatto sulla qualità della vita delle persone e alle loro implicazioni per il pianeta.
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha recentemente adottato un documento di sintesi che articola l’idea in modo più dettagliato.
Per raggiungere l’economia sostenibile che ci serve, l’UE deve proporre «nuova visione di prosperità per le persone e il pianeta, basata sui principi della sostenibilità ambientale, del diritto a una vita dignitosa e della protezione dei valori sociali».
Il “parere di iniziativa” del CESE sottolinea che per raggiungere un’economia del benessere è necessario operare cambiamenti fondamentali sulla natura delle imprese, nell’organizzazione del lavoro, nel ruolo degli investimenti e nella struttura del sistema monetario.
Inoltre, indica in che modo raggiungere l’allineamento fiscale, regolamentare e monetario affinché la transizione verso un’economia a emissioni zero risulti efficace. In particolare, il parere propone l’adozione di un bilancio del benessere, simile a quello adottato in Nuova Zelanda, chiedendo la fine di sussidi iniqui e l’allineamento di ogni tassa, sussidio e impegno di spesa con l’obiettivo di una transizione equa verso un’economia del benessere sostenibile e inclusiva.
Gli obiettivi gemelli dimisurare ciò che conta e spostarsi verso un’economia del benessere sono essenziali per superare la crescita del Pil come modello per il progresso sociale. Entrambi hanno radici profonde nel pensiero economico e ultimamente godono di rinnovato interesse. Tuttavia, è improbabile che senza una strategia, questi percorsi riescano a modificare i modelli di comportamento economico o a spostare gli orientamenti politici, anche perché siamo consapevoli di quelle forze potenti che ci costringono dentro schemi di crescita insostenibile.
Ad esempio, la ricerca della crescita è strettamente legata alla ricerca della produttività del lavoro. Poiché gli imprenditori cercano di ridurre i costi di produzione, tendono a investire in tecnologie di risparmio del lavoro, che riducono il numero di persone necessarie per un determinato livello di produzione. Se queste “efficienze” vengono riprodotte su larga scala, il livello di disoccupazione tende a salire, salvo che l’economia nel suo insieme non si espanda: ecco che tale modello vincola la sicurezza dei posti di lavoro alla crescita del Pil.
Con entrate fiscali principalmente dipendenti dal reddito, anche la sostenibilità fiscale tende a rimanere ancorata alla crescita del Pil. Le misure in materia di salute, assistenza sociale, istruzione e protezione ambientale subiscono la stessa dinamica.
Al contempo, i rendimenti degli investimenti e i prezzi delle azioni tendono a rispondere in modo prociclico, aumentando quando l’economia si espande e diminuendo quando si ritrae, e rendendo vulnerabili alle fluttuazioni del tasso di crescita le pensioni, gli investimenti e la stabilità del mercato azionario.
Il sistema economico convenzionale contiene una complessa serie di “dipendenze da crescita” che resistono al cambiamento.
La ricerca della crescita del Pil resta la posizione politica predefinita, nonostante si sappia quanto sia imperfetta e quanto l’impatto di una crescita economica continua sia insostenibile.
Per questo, si cerca di comprendere e mitigare le “dipendenze da crescita”. Ad esempio, il citato parere del CESE afferma che la transizione verso un’economia del benessere inizia con l’adozione di un “approccio precauzionale” in cui la stabilità sociale non dipende dalla crescita del Pil.
Un gruppo di 238 accademici in tutta Europa ha recentemente scritto una lettera aperta invitando i governi a “porre fine alla dipendenza da crescita” dell’economia europea. Una petizione sullo stesso tema ha raccolto finora oltre 90mila firme. Il Parlamento europeo ha tenuto la sua prima Conferenza Post-Growth a settembre 2018 e ne terrà una seconda entro la fine dell’anno.
Questi inviti a ridurre la dipendenza da crescita sono sostenuti da un recente rapporto del governo tedesco, che presenta un approccio precauzionale di “post-crescita” mondiale. Il rapporto chiede di impostare politiche efficaci considerando la probabilità di una crescita economica diversa da quella che è stata storicamente, soprattutto considerati gli obiettivi ambientali e sociali chiave.
Il rapporto sostiene l’avvio di politiche volte alla riduzione della dipendenza da crescita. Tassare le emissioni piuttosto che il lavoro (ad esempio) ridurrebbe i costi per i datori di lavoro, sposterebbe gli incentivi lontano dagli investimenti di capitale labour-saving verso modelli meno dannosi di produzione e consumo.
Esistono anche opportunità per nuovi modelli di previdenza sociale, assistenza sanitaria e regimi pensionistici maggiormente svincolati dalla crescita economica. Anche modifiche importanti nelle normative monetarie e fiscali che guidano oggi l’azione di governo possono giocare un ruolo fondamentale nella riduzione della dipendenza da crescita.
Esplorare e articolare queste strategie richiede chiaramente un certo grado di volontà politica e un investimento significativo nella ricerca e nell’innovazione “post-crescita”. Ma, alla luce del rallentamento a lungo termine del tasso di crescita cui abbiamo già assistito nelle economie avanzate e delle potenziali minacce alla crescita economica derivanti dal cambiamento climatico, dalla perdita delle biodiversità e dalle perturbazioni sociali, tale strategia risulta pienamente coerente con la prudenza economica.
È essenziale ragionare sulle modalità per garantire un benessere sociale continuo in un ambiente post-crescita, soprattutto oggi che la crescita non può più essere data per scontata.
Tim Jackson è un economista ecologico britannico, professore di Sviluppo sostenibile all’University of Surrey e direttore del Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity – CUSP (il Centro per la comprensione della prosperità sostenibile).
Questo articolo è tratto dal paper di Tim Jackson “Wellbeing MattersTackling growth dependency”. Traduzione a cura di Viola Nicodano. Si ringrazia Valori.it