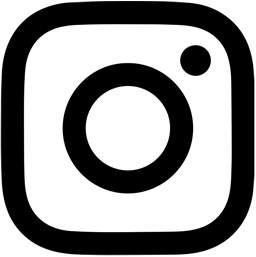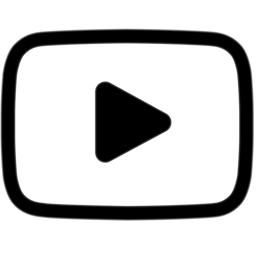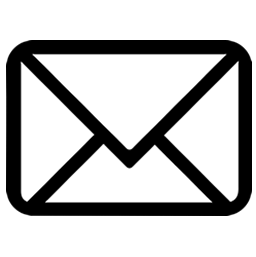Dall’introduzione de “Il giornalismo fatto in pezzi”, di Massimo Fini, da oggi in libreria. Un libro di un amico, un grande uomo e inestimabile giornalista.
“Il lettore non troverà qui editoriali, commenti, opinioni. Di raccolte di questo genere ne avevo già fatte due (Il Conformista, 1990 e Senz’Anima, 2010). Aggiungerne una terza sarebbe stato, oltre che presuntuoso (Indro Montanelli ne ha fatte due) inutile. In questo libro raccolgo la mia attività di cronista, di inviato, di inchiestista, che va dai primi anni Settanta ai Duemila e oltre. E attraverso questa passa uno spaccato della vita italiana di quegli anni. È un giornalismo in presa diretta, fatto di racconti di vita, delle testimonianze di uomini e donne dall’estrazione sociale e dalle esperienze più diverse, di ritratti di personaggi famosi, politici ma soprattutto artisti e letterati la cui memoria affonda spesso ancora più lontano, nel periodo fascista e della guerra. È un giornalismo molto diverso da quello che si fa oggi, che usa e abusa del ricorso al web, ma comune ai colleghi della mia generazione e di alcune successive. Diceva Nino Nutrizio, direttore de La Notte, un grande della nostra professione, se vogliamo elevare questa ‘arte minore’ a quel livello, che il nostro “è un mestiere che si fa prima con i piedi e poi con la testa”. Intendendo che bisogna uscire dalle redazioni, guardare, osservare, annusare e soprattutto ascoltare (direi che la capacità di ascolto è decisiva non solo in giornalismo ma nella vita di tutti i giorni e anche per la riuscita degli artisti o dei grandi manager). La testa viene dopo ed è dare al materiale che si è raccolto un senso. La lezione io la appresi da Tommaso Giglio, il mitico direttore dell’Europeo degli anni Settanta, quando ero ancora un ragazzo. Rifacendosi alla tradizione di Arrigo Benedetti, fondatore del settimanale, Giglio portò al massimo livello il giornalismo di reportage rendendolo una scuola: storie, racconti, personaggi, tutti dal vivo. Una delle forze di quell’Europeo era andare sui piccoli fatti della vita quotidiana, specie di provincia, e farli diventare, grazie a una lente d’ingrandimento e al significato più generale che si riusciva a darne, dei grandi fatti nazionali. Giglio voleva che nemmeno un fonema fosse raccolto non dico attraverso email, che allora non esisteva ancora, ma nemmeno per telefono. La persona la dovevi vedere in faccia. Giglio era addirittura maniacale in questa smania delle interviste che darà poi origine a quello che è stato chiamato il “Fallaci style”. Mi ricordo che per intervistare non so più quale allenatore di uno sport marginale dovetti fare Milano-Trieste-Milano in giornata. Riuscii a malapena a vedere Piazza Unità. Era un giornalismo estremamente faticoso, a volte massacrante. Per un’inchiesta sui quindicenni, è solo un esempio, dovetti fare in pochissimi giorni il giro d’Italia: Milano, Torino, Roma, Bari, Trapani e altre località minori. Ma il peggio veniva quando moriva un grande personaggio dello spettacolo e io dovevo ricostruirne la personalità attraverso chi lo aveva conosciuto da vicino: si trattava di abbordare, in soli tre giorni, uomini altrettanto famosi non usi a darsi facilmente o di rintracciare antiche amicizie perse nel tempo. Il lettore ritroverà qui, fra gli altri, i ritratti di Luchino Visconti, di Vittorio De Sica, di Anna Magnani, di Ermanno Olmi, di Curzio Malaparte. Ci sono anche grandi imprenditori e politici “visti da vicino”: uno su tutti Gianni Agnelli, una lunga confessione di Angelo Rizzoli, Aldo Moro, la singolare figura di Giangiacomo Feltrinelli. E poi le grandi aziende: la Fiat, l’Olivetti di Adriano, la Montedison del prima e dopo Cefis, l’Alfa Romeo. Vi si racconta anche la lenta ma inesorabile decadenza della borghesia a favore di una partitocrazia sempre più invadente, processo che era già iniziato nei primi anni Sessanta, e di una media borghesia senza ideali, abbagliata dal benessere. Se, come afferma Benedetto Croce, “la Storia è il passato visto con gli occhi del presente”, chi legge questo libro potrà, con gli occhi dell’uomo di oggi, trovarvi cosa rimane di quelle stagioni, di quelle speranze, di quelle illusioni e disillusioni. Ma i pezzi che mi offrivano maggior respiro erano quelli che mi dava Pierluigi Magnaschi, direttore della Domenica del Corriere. Dovevo andare in vari paesi del mondo e cercare di descriverli in un tempo adeguato. Ma il tempo non è mai adeguato, fra di noi si dice che se un giornalista va in un posto e ci resta un giorno scrive un articolo, se ci sta un mese scrive un libro, se ci sta un anno non scrive più nulla tanto complessa è la realtà, è ciò che tormentava quel grande collega che è stato Kapuscinski riguardo alla cultura indiana. Mi diceva Oriana Fallaci quando stavo scrivendo una sua biografia poi abortita: “Con questo libro tu devi fare un panegirico di questo mestiere, del giornalista, di questo personaggio straordinario che va in paesi di cui non conosce la lingua, non conosce la geografia, non conosce la storia, non conosce nulla, e torna indietro con un grande racconto col quale, a intuito, ha penetrato lingua e storia e umanità del posto in cui è stato”. L’intuizione è assolutamente necessaria al giornalista. E anche, bisogna pur dirlo, l’invenzione pura e semplice. Tutti i grandi del nostro mestiere, da Malaparte a Montanelli, si sono inventati molte cose. Ma bisogna saperlo fare. Perché il verosimile è alle volte più vero del vero. Disse Ettore Della Giovanna a proposito di Malaparte: “Lui l’ha scritto ed è diventato vero”. Comunque, per tornare a Magnaschi e non solo a lui, si trattava di andare in giro, col taccuino in tasca, per cercare di descrivere la way of life di un paese senza interpellare sociologi, psicologi, antropologi, politici e altri intermediari. In quei reportage potevo unire le mie qualità di giornalista, sempre che ci siano, a quelle di scrittore, ammesso e non concesso che ci siano anche queste. Si va in giro, a zonzo, ma in modo diametralmente opposto a quello del turista. Non sono i monumenti che contano (sono stato una mezza dozzina di volte al Cairo e le piramidi le ho viste solo di sfuggita) ma gli ambienti, i modi di fare e del vestire, i colori, i dettagli. Perché a volte è da un dettaglio, come diceva appunto Fallaci, che puoi cogliere l’insieme. Così nascono, fra gli altri, i servizi sull’Unione Sovietica, sull’Iran, sull’Egitto, su Israele, sul Sudafrica e quello sul Giappone, del 2008, che è l’ultimo di questo genere. Questi reportage, nel raffronto fra culture e società a volte omologhe, altre molto diverse, ci aiutano a capire meglio qual è stato, qual è e quale potrà essere il ruolo dell’Italia in un mondo divenuto globale. Il libro si chiude con lo sguardo a un futuro che è già presente. Nel marzo del 1982 pubblicai un’inchiesta alla quale Aldo Canale ed io demmo il titolo “Scienza amara”. Si tratta della “questione epocale” dell’ambiguità e dell’ambivalenza della Tecnica, ma sarebbe più preciso dire della Scienza tecnologicamente applicata, posta a metà degli anni Trenta da Martin Heidegger, l’ultimo filosofo comparso nell’orizzonte speculativo occidentale, molto influenzato, attraverso Nietzsche, dal pensiero presocratico, preplatonico, prearistotelico e in definitiva, se non antiscientifico, certamente prescientifico. Oggi cominciano ad affiorare dei dubbi sulla Scienza, finora idolo incontrastato, sulla sua capacità taumaturgica di risolvere tutti i nostri problemi. Da parte di una minoranza, che però sempre più si ingrossa, si pensa che la Scienza ci porterà in un vorticoso e velocissimo giro di vite al collasso. Mi ha detto il fisico Edoardo Amaldi, uno dei padri dell’Atomica e che quindi se ne intendeva: “L’uomo se può fare una cosa, prima o poi la fa”. Io penso invece che si dovrebbe recuperare il profondo senso del limite che la cultura greca aveva e che noi abbiamo pericolosamente perduto. Per Scienza amara andai a Ginevra a intervistare Carlo Rubbia, che allora dirigeva il CERN. Rubbia, scienziato, positivista, illuminista, mi ricevette molto di malavoglia, in maniera scontrosa e quasi sgradevole. Mi riteneva, secondo la classica distinzione di Umberto Eco, un “apocalittico”. A mia volta infastidito gli dissi: “Senta professor Rubbia, lei è un fisico e le pongo una domanda alla quale vorrei una risposta da fisico: non è che andando avanti a questa velocità e sempre aumentandola, noi stiamo accorciando il nostro futuro?”. Rubbia restò per un attimo pensieroso. Poi disse: “È così”. Qui sono in gioco non solo il nostro futuro ambientale, che è questione ormai avvertita dai più, ma il concetto di progresso come l’abbiamo concepito finora e soprattutto il futuro dell’uomo che, in una perversa inversione dei ruoli rispetto a Blade Runner, potrebbe diventare un semplice replicante della macchina. Scrissi queste cose ormai quarant’anni fa. Irrise allora, sono diventate temi di strettissima attualità”.