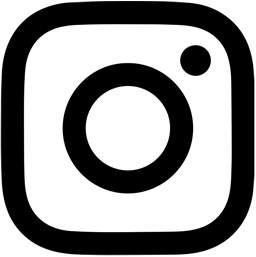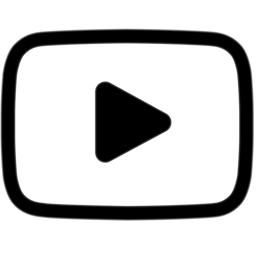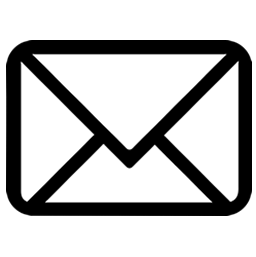di Rafa Sienda – E’ passato più di un mese dalle elezioni distrettuali di Hong Kong, che hanno visto i molti partiti del cosiddetto campo “pro-democrazia” conquistare gran parte dei seggi cittadini, ben 388 (81,5%) contro gli 89 (18,5%) ottenuti dal campo unionista “pro-Pechino”, ribaltando completamente la situazione emersa dalla tornata di quattro anni prima, quando la situazione aveva visto i secondi in netto vantaggio sui primi con 331 seggi a 124. Sul piano politico si è trattato di un segnale importante perché quel voto aveva ormai assunto un significato politico di portata superiore al suo effettivo valore, che in sé coinvolge la semplice gestione dei quartieri dell’area urbana, tornata sotto la sovranità cinese nel 1997, dopo 150 anni di dominazione coloniale britannica (intervallati da 4 anni di occupazione militare giapponese nel 1941-1945), un controllo inizialmente esercitato soltanto sull’isola di Hong Kong propriamente detta, poi esteso alla Penisola di Kowloon e ai cosiddetti Nuovi Territori tra il 1860 e il 1898.
Con un’affluenza-record del 71%, molti elettori hanno voluto dire la loro in una chiamata alle urne trasformatasi in una sorta di referendum consultivo sulle proteste contro la governatrice Carrie Lam – accusata per aver tentato di introdurre una controversa legge sull’estradizione, poi ritirata – che da mesi stavano destabilizzando lo scenario, tradizionalmente tranquillo, della prospera Hong Kong. Il sistema maggioritario, che assegna ciascun seggio al candidato più votato, ha tuttavia offuscato il dato reale del consenso elettorale. In numeri assoluti, infatti, i 39 partiti e i candidati indipendenti che compongono il campo “pro-democrazia” hanno collezionato 1.674.083 voti contro 1.233.030 ottenuti dai 10 partiti e dai candidati indipendenti che si riconoscono nel campo “pro-Pechino”.
Considerando i voti totali, pari a 2.943.842 voti, il rapporto delle forze in campo vede sì in vantaggio le forze più ostili a Pechino ma con il 57,1% contro il 42,05% delle forze unioniste. Insomma, in termini reali la situazione è molto meno sbilanciata di quanto possa far pensare il riparto maggioritario dei 479 seggi complessivi.
Altro elemento da tenere in considerazione è che le forze che oggi compongono il fronte “pro-Pechino” sono quasi tutte assimilabili ad un’area che, se rapportata a parametri europei, potremmo definire di centrodestra. La forza politica più importante all’interno della coalizione unionista – e nel Consiglio Legislativo di Hong Kong – è infatti rappresentata dai conservatori dell’Alleanza Democratica per il Miglioramento e il Progresso di Hong Kong (DAB) che, con circa 492.000 voti, si è confermata primo partito anche in questo voto distrettuale, davanti al Partito Democratico, di ispirazione socio-liberale e socialdemocratica, prima forza del campo “pro-democrazia” con 362.000 voti.
Malgrado lo scontro politico tra i due blocchi politici di Hong Kong sia apparentemente incentrato sul tema della rappresentanza democratica e delle libertà civili, in realtà i sei mesi di scontri e violenze, con le loro simbologie e i loro slogan, hanno dimostrato che il conflitto in atto riguarda l’appartenenza territoriale della regione. Prima degli accordi del 1984 tra Deng Xiaoping e Margaret Thatcher, con cui furono sostanzialmente approntati e definiti i termini per la restituzione concordata del territorio alla Cina, a Hong Kong non esisteva una vera e propria democrazia. Per un secolo e mezzo, la Corona di Londra ha nominato direttamente il governatore locale, sempre un inglese, tutt’al più coadiuvato da un organismo consultivo locale di scarso peso e rappresentatività.
Il Consiglio Legislativo si è di fatto sostanziato, potendo esprimere appieno le sue funzioni, soltanto dopo il 1997, quando entrò definitivamente in vigore la Legge Fondamentale di Hong Kong, un testo costituzionale approvato a Pechino nel 1990 che delinea in modo dettagliato e specifico il modello Un Paese, due sistemi, pensato da Deng Xiaoping per garantire alla regione una forte autonomia esecutiva, legislativa e giudiziaria nel quadro della sovranità cinese. Per venire incontro alle esigenze dell’ex colonia britannica fu introdotta una nuova suddivisione territoriale, quella della Regione Amministrativa Speciale (SAR, nella dicitura anglosassone), che fece scuola anche per Macao, l’ex colonia portoghese restituita alla Cina nel 1999, dopo oltre quattro secoli di alienazione territoriale.
Il processo di costruzione democratica di Hong Kong partiva dunque certamente da un elevato livello di sviluppo economico e finanziario, garantito dal sistema liberale anglosassone, capace di fare della regione una delle quattro originarie “tigri asiatiche”, almeno fino alla crisi finanziaria asiatica del 1997. Tuttavia, ciò avveniva nel contesto di una dominazione coloniale straniera priva di effettivi organismi democratici che fossero espressione della popolazione locale.
Oggi, l’economia di Hong Kong continua costantemente a crescere (la regione è la 33a economia mondiale, la quinta piazza finanziaria e il terzo mercato più business-friendly al mondo) ma il governatore di Hong Kong è solo formalmente nominato dal primo ministro cinese perché in realtà viene prima votato dalla Commissione Elettorale. Questo organismo locale è formato da 1200 membri, appartenenti a quattro categorie di vario genere: 300 provengono dal mondo dell’industria e della finanza, 300 dalle professioni, 300 dall’agricoltura e servizi sociali ed altri 300 sono membri che rappresentano, in varie quote, il Consiglio Legislativo, i Consigli Distrettuali, l’organo consultivo Heung Yee Kuk, i deputati e membri di Hong Kong eletti all’Assemblea Nazionale del Popolo (il parlamento centrale cinese) e alla Conferenza Politico-Consultiva del Popolo (il massimo organo consultivo cinese). Con questo sistema, due anni e mezzo fa Carrie Lam è stata eletta governatrice di Hong Kong con il 66,81% dei voti.
I meccanismi di composizione del Consiglio Legislativo seguono un copione analogo. Dopo la riforma del 2012, la metà dei 70 membri che ne fanno parte sono votati a suffragio universale, 30 sono espressione delle professioni ed altri 5 sono eletti tra i rappresentanti dei Consigli Distrettuali. Qui si inserisce una parte della protesta di strada, per lo meno quella più pacifica, che chiede il suffragio universale per l’intero processo elettivo dell’organismo. L’articolo 68 della Legge Fondamentale stabilisce che «il metodo di formazione del Consiglio Legislativo deve essere specificato alla luce dell’effettiva situazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e in base al principio del progresso graduale e ordinato», aggiungendo infine che l’obiettivo finale è esattamente quello di estendere il suffragio universale all’intera composizione del Consiglio.
Gli incidenti e le aggressioni, tuttavia, hanno messo in luce qualcosa di diverso. Non la semplice richiesta di accelerare un disegno di riforma già previsto da Pechino e dalle autorità locali ma la chirurgica intenzione di paralizzare le attività quotidiane di Hong Kong, bloccando le linee della metropolitana, distruggendo i semafori stradali, assaltando filiali bancarie cinesi fino a fare irruzione nella sede del Consiglio Legislativo, vandalizzandone i locali. Lasciano ancora perplessi le immagini di qualche mese fa che ritraggono i manifestanti più violenti impegnati a sventolare bandiere britanniche o statunitensi, o addirittura la bandiera coloniale della vecchia Hong Kong, quando la metropoli era spesso governata da Londra col pugno di ferro, almeno fino agli anni Settanta del secolo scorso.
La richiesta di aiuto indirizzata a Donald Trump dalle frange più facinorose della protesta è finora caduta nel vuoto. Tuttavia, Washington, così come altri Paesi occidentali, ha finora interferito nelle questioni di Hong Kong approvando un apposito decreto, il cosiddetto Hong Kong Human Rights and Democracy Act, ed insinuandosi nella regione come già avevano fatto fondazioni non-governative statunitensi quali la NED (National Endowment for Democracy), l’IRI (International Republican Institute) e l’Open Society. Dal canto suo, Pechino non è intervenuta con le sue forze armate, come invece diversi media occidentali avevano ipotizzano, lasciando che fosse la polizia locale, armata in modo non letale (le pistole in dotazione sparano proiettili di gomma), a risolvere la situazione.
La stampa della Cina continentale si è tuttavia chiesta cosa sarebbe accaduto se in un qualsiasi Paese occidentale si fossero verificati fatti così gravi e violenti per un periodo tanto prolungato. In Francia, ad esempio, la protesta dei gilet gialli, nel corso dei suoi primi due mesi ha lasciato sul campo 12 morti tra i manifestanti e migliaia di feriti, compresi gli agenti di polizia. A Hong Kong, in oltre sei mesi di proteste, si contano due morti: un ragazzo di 22 anni, caduto accidentalmente da un parcheggio sopraelevato durante una protesta lo scorso ottobre, ed un uomo di 70 colpito alla testa da un mattone quasi certamente lanciato da un manifestante.
Ci sono così due piani di discussione sui quali varrà la pena ragionare: il confronto politico, anche serrato e determinato, interno alla regione e lo scontro sull’appartenenza geopolitica di Hong Kong, che una corposa minoranza dei manifestanti vorrebbe fuori dalla Cina, presumibilmente alleata degli Stati Uniti, sull’esempio di Taiwan. Eppure, esattamente come nella “provincia ribelle”, anche a Hong Kong sanno che il diritto internazionale è dalla parte di Pechino, che non ha esitato a ribadire che l’ex colonia britannica resta indiscutibilmente parte integrante del territorio nazionale cinese.