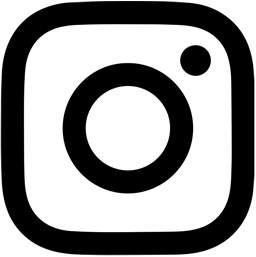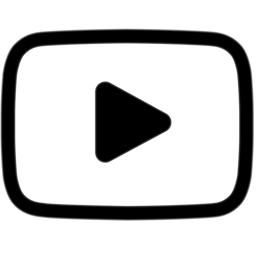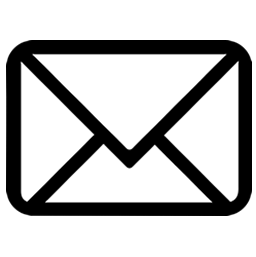di Giuseppe Conte – In un suo scritto, «Il existe une culture européenne» Julia Kristeva, nell’interrogarsi sull’identità europea, apre a una suggestione di grande respiro: «La migliore risposta europea alla domanda: Chi sono?» – scrive l’intellettuale francese di origine bulgara – «non è ovviamente la certezza, ma l’amore per il punto interrogativo».
Colgo, in queste parole, la consapevolezza delle fratture che, ormai da decenni, attraversano il continente, dei conflitti ancora irrisolti fra molteplici cifre identitarie, geografiche, sociali, linguistiche, fino alle più recenti tensioni generazionali, di genere, di alfabetizzazione digitale, di sensibilità ambientale. E tuttavia, intravedo anche l’urgenza di una risposta, la ricerca di una chiave di lettura che permetta di affrontare la crisi – le tante crisi – che l’Europa ha conosciuto in questi ultimi anni.
È forse solo dentro un perimetro ampio e dai confini ancora incerti che possiamo trovare il senso del percorso che ha portato alla costruzione dell’edificio europeo, declinato in forme e istituti complessi, certamente non privi di criticità e aporie. L’Unione europea è stata l’esito di un processo di continue approssimazioni, caratterizzato da profetiche accelerazioni e lunghe fasi di stasi, in tensione continua tra prospettive visionarie e faticosa gestione dell’ordinario.
La congiuntura storica nella quale ci muoviamo ci sfida: abbiamo attraversato due crisi finanziarie di vastissima portata, quella del 2008-09 e quella del 2011-12; abbiamo affrontato e vinto la sfida epocale della pandemia; siamo nel pieno di un conflitto armato in atto nel cuore del Continente e assistiamo alla tragica apertura di un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente, dagli esiti imprevedibili e dalle conseguenze devastanti.
Di fronte a tutto questo, siamo chiamati a operare uno sforzo comune, alimentato da grande senso di responsabilità: abbiamo il compito di rilanciare il progetto europeo, facendogli riacquistare credibilità e coesione, accrescendone la sostenibilità, l’efficacia, la plausibilità. Dobbiamo recuperare – per tornare alla suggestione della Kristeva – la sua più profonda identità.
Tanto più questo è vero oggi, alle soglie di un appuntamento elettorale – il rinnovo del Parlamento europeo – di estrema importanza per il riassetto degli equilibri politici, per la conseguente ridefinizione delle priorità fra le policies che l’Unione dovrà perseguire e, in generale, per il futuro dell’Europa.
La sfida più severa e pervasiva che l’Europa è stata chiamata ad affrontare in questi ultimi anni è stata, oggettivamente, l’emergenza pandemica. In quell’occasione, l’Europa ha reagito allo shock e ha risposto in maniera efficace e per più di un verso innovativa.
La novità più significativa è stata la creazione di uno strumento, «Next Generation EU», che ha previsto un ingente piano di finanziamenti, destinati non solo a riparare i danni economici e sociali prodotti dalla crisi pandemica, ma anche a stimolare la ripresa e una maggiore resilienza degli Stati membri.
Credo che questa iniziativa abbia impresso una svolta significativa nella storia dell’Unione europea, scandendo un salto di qualità nel processo di integrazione: Next generation EU – con il dispositivo per la ripresa e la resilienza – può infatti aprire la strada alla possibilità di un meccanismo permanente di investimenti, che poggia sulla emissione di debito comune. Oggi quel programma è in sofferenza per le difficoltà riscontrate nella fase attuativa e di implementazione, che – come è noto – è rimessa ai Piani nazionali di ripresa e resilienza e, quindi, alla capacità realizzativa dei singoli Paesi membri.
L’Italia, che ha trasmesso alla Commissione europea il suo Piano il 30 aprile 2021, ha vissuto una fase critica, che ancora adesso non appare risolta. Lo sblocco della 3a rata, connessa al conseguimento degli obiettivi del secondo semestre del 2022, ha comportato un ritardo complessivo, che comunque rischia di compromettere la piena attuazione del Piano nei tempi stabiliti. Infatti, non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo dei 27 target, programmato originariamente per il 30 giugno di quest’anno. A questi target, ai quali si è aggiunto un altro target in origine collegato alla 3a rata e non conseguito in tempo utile, è infatti collegata l’erogazione della 4a rata, pari a una cifra di 16,5 miliardi.
Inoltre, il Governo italiano ha presentato una riprogrammazione del Piano, che deve ancora ottenere l’approvazione delle competenti istituzioni dell’Unione europea. Certamente questa incertezza e questa approssimazione sono fonte di preoccupazione, perché agli investimenti del PNRR l’Italia ha affidato le sue maggiori prospettive di sviluppo futuro e di modernizzazione, come giustamente è stato segnalato in un editoriale del Financial Times dello scorso 5 settembre.
Su questo occorre la massima responsabilità, nella piena consapevolezza che è in gioco la credibilità del Paese e il futuro delle nostre più giovani generazioni. Nessuno più di me ne è conscio, avendo io stesso promosso l’avvio di questo percorso, che può cambiare completamente le politiche europee, invertendo radicalmente i passati indirizzi.
Per scongiurare questo rischio e far sì che questa iniziativa, pur nata nel contesto di una specifica, severa crisi economica e sociale, sia stabilmente acquisita nel quadro delle politiche europee, occorre non rinunciare a nessun obiettivo, rispettandone la tempistica. Essere riusciti a mobilitare un ammontare così significativo di risorse, finalizzate a obiettivi di investimento in linea con le priorità europee e finanziate con debito comune, è stato un successo per l’Italia e un passaggio decisivo per invertire il paradigma dell’austerità, su cui si era basata la risposta delle Istituzioni europee alle crisi del passato. Non essere in grado di utilizzare oggi quelle risorse sarebbe un errore di portata storica.
Nella congiuntura storica che stiamo vivendo, l’Europa deve guardare anche ad altri obiettivi, altrettanto prioritari, ai quali offrire un contributo originale e consapevole dei nostri interessi.
Innanzitutto, occorre più coraggio nella grande partita della riforma della governance economica dell’Unione europea, favorendo un effettivo equilibrio fra condivisione e riduzione dei rischi. Le soluzioni prospettate destano perplessità.
La proposta della Commissione tende a riproporre i consueti parametri di finanza pubblica, di cui le crisi degli ultimi quindici anni hanno mostrato tutta la loro inadeguatezza. Sarebbe necessario un indirizzo maggiormente orientato a costruire un sistema che – nella verifica sulla stabilità del Paese – tenga conto degli investimenti pubblici, soprattutto nella sfera della transizione ecologica e digitale, scorporandoli dalla misurazione del disavanzo. Questo perché la spesa per gli investimenti, tanto più in settori strategici per il futuro dell’Unione, non è un mero costo, ma è il presupposto della crescita futura.
In questa prospettiva, ritengo che anche la politica degli aiuti di Stato debba cambiare.
La tragica esperienza della pandemia e la guerra in Ucraina hanno insegnato molto in proposito, anche considerando che l’Europa ha dovuto fronteggiare le scelte delle altre potenze mondiali che, per sostenere le proprie industrie nazionali, hanno approvato l’erogazione di corposi sussidi pubblici, suscettibili di alterare la concorrenza sui mercati globali. Mi riferisco, in particolare, all’Inflation Reduction Act (IRA) statunitense, che prevede cospicui investimenti, che mirano, tra le altre cose, a sostenere la competitività e la eco-compatibilità della produzione statunitense.
Come può l’Unione non rispondere, unita e decisa?
Per questo ritengo che, accanto alla riforma della governance economica, sia necessario procedere con altrettanta determinazione alla revisione della disciplina non emergenziale sugli aiuti di Stato, valevole per il nuovo periodo programmatorio 2021-2027.
Nessuna riforma delle politiche fiscali sarà efficace, però, se non sarà accompagnata da coraggiose politiche per il lavoro, che siano realmente in grado di restituire «dignità sociale» ai cittadini europei.
La sfida per un’Europa sociale sarà vinta solo impegnandosi, con la massima determinazione, per creare strumenti efficaci contro la disoccupazione e a protezione dei salari. Questi obiettivi non sono un fattore di deficit e di instabilità, ma un volano per il futuro del nostro Continente e il miglior antidoto contro le derive nazionalistiche. Su questo, tutte le forze progressiste d’Europa, in vista dell’imminente appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, non possono dividersi, pena la perdita della comune vocazione al progresso e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei, soprattutto di coloro che vivono in condizioni di deprivazione materiale, disagio sociale e di precarietà lavorativa. Occorre continuare a stare insieme e condividere battaglie comuni, sostenendo misure coraggiose, orientate alla protezione e alla crescita. Tra queste, ho sempre considerato prioritaria e qualificante la creazione di un’assicurazione europea contro la disoccupazione. In questa prospettiva, lo strumento SURE va nella giusta direzione, ma deve essere ulteriormente implementato, rendendolo strutturale e disponibile per i Paesi membri, proprio nei momenti in cui il ciclo economico è sfavorevole, quando le sole risorse nazionali non sarebbero sufficienti a sostenere le crisi occupazionali.
L’Europa non può farsi trovare impreparata, peraltro, rispetto alla nuova rivoluzione innescata dall’Intelligenza Artificiale, che, se da un lato, appare suscettibile di sostenere – attraverso le sue numerose applicazioni industriali e tecnologiche – un robusto incremento della crescita economica, dall’altro lato appare insidiosa per le ricadute negative sul piano occupazionale, soprattutto in settori come il diritto, la medicina, la finanza, l’informazione e l’intrattenimento.
Molti studi internazionali attestano che l’impatto negativo sul piano occupazionale sarà compensato dalla creazione di nuove figure professionali, ma è evidente che nel periodo transitorio ci ritroveremo esposti a forti scompensi, a cui dovremo porre rimedio con adeguate politiche di sostegno reddituale.
Saranno tutti temi al centro della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, sulle quali – lo ripeto – si misurerà la capacità delle forze progressiste di offrire ai cittadini europei un progetto alternativo alle destre.
Dobbiamo essere in grado di mantenere l’elettorato e di attrarre quei cittadini europei, soprattutto i giovani, sfiduciati e delusi. Molto dipenderà dalla capacità dei partiti progressisti di avanzare insieme proposte credibili e coraggiose, per invertire radicalmente il paradigma su cui si è strutturato il mercato unico e abbracciare una visione più avanzata, ancorata più saldamente al valore della persona umana colta nella concretezza della sua esistenza.
Al centro dell’agenda europea vi è poi, senza dubbio, la grande sfida della transizione ecologica. L’accelerazione su tutti gli obiettivi di decarbonizzazione deve essere una assoluta priorità, in linea con la proposta, avanzata dalla Commissione, di un regolamento, il cosiddetto Net Zero Industry Act, sull’istituzione di un quadro di misure per il rafforzamento dell’ecosistema europeo di realizzazione di prodotti a tecnologia «zero emissioni».
Nella prospettiva della transizione energetica, una declinazione particolare, per le ricadute che essa può avere sul tessuto produttivo e in termini di occupazione, è il passaggio definitivo, nel 2035, agli autoveicoli elettrici.
L’Italia, pur assicurando di essere pienamente impegnata nell’obiettivo di decarbonizzazione del settore del trasporto stradale, ha manifestato, con il governo Meloni, un’eccessiva prudenza. Continue prese di posizioni cautelative ci allontanano dall’asse principale verso cui si stanno indirizzando non solo l’Europa, ma tutte le grandi economie avanzate. Ma c’è di più. Mostrando troppa incertezza, rischiamo di perdere alcune partite decisive, che, da una parte, consentono di accompagnare la transizione all’elettrico con interventi di sostegno ai settori più colpiti e, dall’altra, permettono di abbattere i costi del passaggio al nuovo modello.
Lungi dal manifestare incertezze, l’Italia dovrebbe abbracciare in tutta la sua portata e radicalità il percorso verso la completa elettrificazione. Il mondo intorno a noi – dalla produzione alla ricerca di avanguardia, fino ai settori industriali avanzati più aperti all’innovazione – è già ben posizionato su questi orizzonti.
Gli obiettivi di net zero emission per il 2050, peraltro, si intrecciano fortemente con le prospettive di autonomia strategica dell’Europa, divenuto tema centrale e urgente a seguito del conflitto in Ucraina, che sta subendo una curvatura molto insidiosa, che costringe ad analisi coraggiose, scevre da condizionamenti ideologici.
Su questo terreno l’Europa si gioca molto.
Come è noto, l’Unione europea ha orientato la sua strategia esclusivamente lungo due assi di intervento: da una parte, misure di carattere restrittivo nei confronti della Russia; dall’altro, la fornitura diretta di armi all’Ucraina o finanziamenti per l’acquisizione di ordigni e munizioni. Non è in discussione né la nostra collocazione atlantica – e, conseguentemente, la condivisione delle scelte di politica militare con i nostri partner storici e naturali, a partire dagli Stati Uniti – né il sostegno al Paese aggredito. Ho sempre dubitato però, che una strategia affidata esclusivamente all’assistenza militare, che bandisca ogni parallela strategia negoziale, potesse realisticamente condurre a una prospettiva di pace.
Il rischio concreto – che ho denunciato da subito – è nel fatto che gli enormi costi sostenuti per perseguire la logica dell’escalation militare e la stanchezza mostrata dalle opinioni pubbliche nazionali inducano i governi che via via si approssimano agli appuntamenti elettorali a marcare un disimpegno sul piano degli aiuti militari, con la conseguenza che l’Ucraina si ritrovi, come già successo per l’Afghanistan nell’agosto del 2021, di colpo abbandonata a se stessa, sopraffatta da una nuova offensiva russa.
Una maggiore autonomia dell’Europa nella gestione della crisi ucraina avrebbe rafforzato anche la sua autonomia strategica, sia in campo energetico sia nel settore della difesa. Su questo, i leader europei hanno mostrato una preoccupante afasia, se si escludono alcune posizioni assunte dal presidente Macron e sintetizzate in un’intervista al quotidiano Les Echos l’11 aprile scorso.
Resto convinto che la strada, certamente faticosa ma ineludibile, che l’Europa deve continuare a perseguire, in linea con la sua più nobile tradizione di politica estera, sia il multilateralismo, modello fondato su una logica di «responsabilità condivisa», sul dialogo e sull’inclusività.
Peraltro, rinunciando ad esperire ogni possibile percorso negoziale rispetto a una crisi geopolitica in atto nel suo territorio, l’Europa ha indebolito la sua posizione nello scacchiere mondiale, accentuando un’immagine di sostanziale irrilevanza.
La debolezza dell’Europa rischia di riemergere tragicamente di fronte alla crisi israelo-palestinese. Siamo rimasti sgomenti di fronte all’orrore perpetrato da Hamas nei confronti dei civili israeliani il 7 ottobre scorso. È stato un atto terroristico brutale e indiscriminato che ha innescato la legittima pretesa di Israele di agire in rappresaglia per difendere il suo popolo.
L’Europa ha riconosciuto da subito il diritto di Israele alla difesa, ma ha contestualmente affermato che quel diritto deve dispiegarsi in conformità al diritto internazionale e al diritto internazionale umanitario, come ha sancito il Consiglio europeo nelle Conclusioni del Vertice del 26 e 27 ottobre scorso.
A mio avviso, l’Unione europea non deve avere timore ad affermare, anche in questa tragica contingenza di guerra, che, accanto al riconoscimento del diritto alla sicurezza del popolo ebraico, permane intatto il diritto dello Stato palestinese ad esistere in piena indipendenza e sovranità, come ribadito nelle molteplici risoluzioni delle organizzazioni internazionali che si adoperano per la promozione della pace e della sicurezza in quella tormentata regione del mondo.
Gli obiettivi di net zero emission per il 2050, peraltro, si intrecciano fortemente con le prospettive di autonomia strategica dell’Europa, divenuto tema centrale e urgente a seguito del conflitto in Ucraina, che sta subendo una curvatura molto insidiosa, che costringe ad analisi coraggiose, scevre da condizionamenti ideologici.
Su questo terreno l’Europa si gioca molto.
Come è noto, l’Unione europea ha orientato la sua strategia esclusivamente lungo due assi di intervento: da una parte, misure di carattere restrittivo nei confronti della Russia; dall’altro, la fornitura diretta di armi all’Ucraina o finanziamenti per l’acquisizione di ordigni e munizioni. Non è in discussione né la nostra collocazione atlantica – e, conseguentemente, la condivisione delle scelte di politica militare con i nostri partner storici e naturali, a partire dagli Stati Uniti – né il sostegno al Paese aggredito. Ho sempre dubitato però, che una strategia affidata esclusivamente all’assistenza militare, che bandisca ogni parallela strategia negoziale, potesse realisticamente condurre a una prospettiva di pace.
Il rischio concreto – che ho denunciato da subito – è nel fatto che gli enormi costi sostenuti per perseguire la logica dell’escalation militare e la stanchezza mostrata dalle opinioni pubbliche nazionali inducano i governi che via via si approssimano agli appuntamenti elettorali a marcare un disimpegno sul piano degli aiuti militari, con la conseguenza che l’Ucraina si ritrovi, come già successo per l’Afghanistan nell’agosto del 2021, di colpo abbandonata a se stessa, sopraffatta da una nuova offensiva russa.
Una maggiore autonomia dell’Europa nella gestione della crisi ucraina avrebbe rafforzato anche la sua autonomia strategica, sia in campo energetico sia nel settore della difesa. Su questo, i leader europei hanno mostrato una preoccupante afasia, se si escludono alcune posizioni assunte dal presidente Macron e sintetizzate in un’intervista al quotidiano Les Echos l’11 aprile scorso.
Resto convinto che la strada, certamente faticosa ma ineludibile, che l’Europa deve continuare a perseguire, in linea con la sua più nobile tradizione di politica estera, sia il multilateralismo, modello fondato su una logica di «responsabilità condivisa», sul dialogo e sull’inclusività.
Peraltro, rinunciando ad esperire ogni possibile percorso negoziale rispetto a una crisi geopolitica in atto nel suo territorio, l’Europa ha indebolito la sua posizione nello scacchiere mondiale, accentuando un’immagine di sostanziale irrilevanza.
La debolezza dell’Europa rischia di riemergere tragicamente di fronte alla crisi israelo-palestinese. Siamo rimasti sgomenti di fronte all’orrore perpetrato da Hamas nei confronti dei civili israeliani il 7 ottobre scorso. È stato un atto terroristico brutale e indiscriminato che ha innescato la legittima pretesa di Israele di agire in rappresaglia per difendere il suo popolo.
L’Europa ha riconosciuto da subito il diritto di Israele alla difesa, ma ha contestualmente affermato che quel diritto deve dispiegarsi in conformità al diritto internazionale e al diritto internazionale umanitario, come ha sancito il Consiglio europeo nelle Conclusioni del Vertice del 26 e 27 ottobre scorso.
A mio avviso, l’Unione europea non deve avere timore ad affermare, anche in questa tragica contingenza di guerra, che, accanto al riconoscimento del diritto alla sicurezza del popolo ebraico, permane intatto il diritto dello Stato palestinese ad esistere in piena indipendenza e sovranità, come ribadito nelle molteplici risoluzioni delle organizzazioni internazionali che si adoperano per la promozione della pace e della sicurezza in quella tormentata regione del mondo.
Da Premier ho sostenuto fortemente l’impegno di Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia per l’avvio dei negoziati di adesione, nonché quelli della Bosnia-Erzegovina per ottenere lo status di candidato all’adesione.
Nel 2022 il processo di adesione di questi Stati ha subito un’accelerazione, a cui è stata impressa una curvatura fortemente condizionata dalla guerra in Ucraina. D’altra parte, nel momento in cui, con il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022, si è accolta la prospettiva europea di Ucraina, Moldova e Georgia, e si è deciso di concedere subito lo status di Paese candidato a Ucraina e Moldova, il quadro cambia.
Il processo di adesione dell’area balcanica si radica, a questo punto, all’interno della più generale strategia contenitiva verso la Russia.
Non c’è dubbio che l’ingresso nell’Unione europea dei Paesi dell’area balcanica possa rappresentare un passaggio centrale in vista di una maggiore autonomia strategica dell’Europa, soprattutto nel settore della difesa.
Tuttavia, un conto sono le logiche e le strategie connesse alla sicurezza del Continente, altro sono i percorsi di integrazione – politica, giuridica, economica – di nuovi Stati all’interno dell’ordinamento dell’Unione europea. Un’accelerazione non accompagnata da adeguate cautele, non assistita da un’attenta verifica del rispetto di alcune condizioni decisive (Stato di diritto, rafforzamento delle istituzioni democratiche, diritti fondamentali, riforma della pubblica amministrazione, sviluppo economico e competitività) è suscettibile di arrecare un danno rilevante al funzionamento delle Istituzioni. Inoltre, il pericolo più imminente è quello di un patologico rallentamento nei processi decisionali, fino al concreto rischio di paralisi, spesso causata dal ricorso al potere di veto proprio da parte di quei Paesi di più recente adesione, meno integrati nell’acquis euro-unitario.
Poniamo la massima attenzione a non favorire quanti, proprio incoraggiando progressivi e rapidi allargamenti, hanno interesse a indebolire l’Unione europea e a comprometterne la sua capacità di agire – in autonomia e con protagonismo – nel contesto geopolitico mondiale.
In questa prospettiva, potrebbe essere riaperta la riflessione su un’Europa a due velocità, di cui peraltro già abbiamo esperienza, dall’Eurozona allo spazio Schengen.
Si potrebbe ripensare la geografia e l’architettura del Continente, senza indebolire l’Unione. Lo stesso presidente Macron, riprendendo peraltro una proposta avanzata nel 1989 dal presidente Mitterand, ha in più occasioni auspicato la creazione di una comunità politica europea più ampia, che consentirebbe di trovare nuovi spazi di cooperazione al di fuori dell’Unione europea.
Anche sulle politiche migratorie occorre più coraggio e maggiore visione.
Occorre investire, sul piano politico e finanziario, nella collaborazione con l’Africa, soprattutto dell’area sub-sahariana, perseguendo nuovi modelli di cooperazione, ispirati al partenariato fra eguali, in grado di accrescere al contempo opportunità e responsabilità e così agire su alcune delle cause più profonde della migrazione.
Non meno complessa è la gestione europea della dimensione interna del fenomeno migratorio.
Ai fini di una riforma globale delle politiche migratorie dell’Unione, nel settembre 2020 la Commissione europea presentò un «Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo», a cui personalmente dedicai molto impegno, nella consapevolezza della sua centralità strategica per un Paese come l’Italia, fortemente esposto alla pressione migratoria lungo le rotte del Mediterraneo, che, lungi dal ridursi, si sta intensificando in misura significativa al punto da creare allarme presso le comunità locali più esposte al fenomeno.
Gli avanzamenti finora registrati sono purtroppo ancora insufficienti. L’Italia non è riuscita a imprimere una svolta decisiva alla politica europea sulla migrazione, né è riuscita a superare le resistenze a ogni forma di solidarietà concreta nel meccanismo europeo di accoglienza e asilo dei migranti, mostrate proprio da parte di quegli Stati governati da forze politiche affini ai partiti che sostengono il governo Meloni, che infatti hanno posto il loro veto nel Consiglio europeo del 29 e 30 giugno scorso, contribuendo a frenare ogni impulso di riforma. Anche nel Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre non si è registrato alcun significativo avanzamento sulla materia migratoria.
Il maggiore obiettivo sul quale si giocherà il futuro del Continente, quello sul quale concentrare tutta l’attenzione e il massimo impegno, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, è il recupero della dimensione pienamente politica dell’Unione, che si traduce nella piena e definitiva creazione di un popolo europeo.
All’esito di questi decenni di integrazione europea, i cittadini europei, soprattutto i più giovani, intendono l’Europa come uno spazio fisico e giuridico unitario, che consente loro ogni giorno il proprio patrimonio di esperienze umane, culturali e professionali, e di condividerlo, accogliendo le specificità nazionali sempre più come declinazioni di una stessa sensibilità, come diverse modalità di partecipare a un «comune sentire».
Il processo di creazione di un popolo europeo è stato fortemente alimentato dalla dimensione giuridica. Al riguardo, è stata fondamentale l’azione svolta, ciascuna nel proprio ambito di competenza, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Giustizia, in stretto raccordo anche con le Corti costituzionali nazionali. Questo sistema avanzato e articolato di tutela giurisdizionale, ormai iscritto con caratteri indelebili nel patrimonio giuridico dell’Unione, rappresenta una conquista di civiltà da difendere e preservare, proprio per gli effetti virtuosi che è suscettibile di produrre nell’immaginario collettivo del cittadino europeo, alimentando la consapevolezza di essere parte di un destino condiviso, di essere popolo nel senso di comunità partecipe di un uniforme sistema di diritti e di un fecondo processo di civilizzazione.
Ancora di più oggi dobbiamo difendere questo modello, minacciato purtroppo al suo interno da decisioni di alcuni Stati membri – emblematici i casi di Polonia e Ungheria – lesive dei diritti e delle libertà costituzionali.
Nessuna concessione può essere tollerata sul rispetto dello Stato di diritto: la tutela delle minoranze, l’indipendenza della magistratura, la correttezza delle procedure elettorali, la lotta contro la corruzione, la libertà di stampa sono valori iscritti nel nostro codice genetico. Nessun Stato, che sia membro dell’Unione o che voglia diventarne membro, può legittimamente e senza conseguenze arretrare su questo terreno.
In questo senso, valuto con molto favore la sentenza del 5 giugno scorso, con la quale la Corte di Giustizia ha accolto il ricorso per inadempimento sollevato dalla Commissione europea contro la Polonia, a seguito dell’approvazione di una legge nazionale riguardante l’organizzazione degli organi della giustizia ordinaria, di quella amministrativa e della stessa Corte suprema, allo scopo di ridurne significativamente l’indipendenza. Si tratta di una decisione molto importante, non solo sotto il profilo del merito, ma anche perché afferma, al massimo livello e senza ambiguità, la centralità dello Stato di diritto, parte dell’identità stessa dell’Unione, che si concretizza in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
Nonostante tutto, però, non siamo riusciti ancora a diventare veramente e compiutamente un «popolo», non abbiamo avuto il coraggio di costruire un modello inclusivo che, realisticamente, al di là di ogni retorica, favorisse la creazione di un demos europeo. È mancato lo slancio «profetico», che invece conobbero i grandi statisti del secondo dopoguerra. Prima della pandemia, l’Unione europea si era fortemente ancorata alla pura dimensione economica, in una prospettiva univocamente orientata all’attuazione di indirizzi liberisti, tesi a favorire privatizzazione di servizi e beni essenziali, riduzione della regolamentazione in settori economici vitali, contrazione del sostegno sociale e delle politiche di welfare, che hanno accresciuto le diseguaglianze nella ricchezza e nelle opportunità. La politica europea si era ritratta impaurita al di qua della fredda grammatica delle procedure, finendo col perdere progressivamente il contatto con il suo popolo e rendendo sempre più incolmabile la distanza, che non è solo geografica, tra Bruxelles e le tante periferie del Continente.
Progressivamente e inesorabilmente la politica aveva rinunciato alla sua funzione legittimante e rappresentativa, apparendo – agli occhi dei cittadini – distante e «oligarchica», incapace di comprendere i reali bisogni della collettività. Era divenuta, come è stato acutamente osservato dal politologo Jan Zielonka, «un parametro cerimoniale a copertura di operazioni globali molto complesse, largamente incomprensibili, se non segrete».
La pandemia e la guerra in Ucraina hanno certamente cambiato tutto questo, ma dobbiamo essere vigili, perché la nuova prospettiva non è saldamente acquisita al patrimonio europeo. Assistiamo a segnali preoccupanti, soprattutto da parte delle forze conservatrici e nazionaliste, di un pericolo ritorno al passato, a modelli di governance inadeguati alle sfide che ci attendono.
Siamo di fronte a un tornante decisivo della storia dell’Europa unita, ci attendono scelte fondamentali per il nostro futuro.
L’europeismo del XXI secolo, a mio avviso, presuppone inevitabilmente un avanzamento delle forme e degli istituti che hanno caratterizzato la storia dell’integrazione degli ultimi trent’anni; richiede, urgentemente, una autentica «conversione», che è anche – per alcuni aspetti – un ritorno alle origini, alle ragioni fondative del sogno europeo.
L’Europa che immaginiamo sarà capace di esprimere una forza propulsiva, non semplicemente stabilizzatrice, nell’interesse dei suoi cittadini, degli Stati membri, degli interessi comuni? Torna preponderante la domanda di senso, suggerita da Julia Kristeva, con la quale ha preso avvio il mio intervento: quale Europa vogliamo? Di quale Europa abbiamo bisogno per garantire ai cittadini europei un futuro all’altezza dei decenni di pace e di prosperità che l’Unione ha assicurato?
La mia risposta è ancora una volta la stessa: l’Europa dev’essere vicina ai suoi popoli. L’Unione Europea, nel XXI secolo, deve perseguire il suo progetto «dal popolo» e «per il popolo». La politica non è una dimensione neutra rispetto alla vita di ciascuno, non è una variabile indipendente, priva di conseguenze sulla nostra esistenza. Già Isocrate, d’altra parte, nell’Aeropagitico, scriveva: «il governo è l’anima della città, e ha tanto potere quanta ne ha la mente nel corpo. Proprio il governo delibera intorno ad ogni questione e si fa custode di ciò che buono. È inevitabile […] che ciascuno viva bene o male a seconda del genere di governo che ha». Nella Politica, Aristotele definisce la comunità ideale quella «nata in vista del vivere, ma esistente essenzialmente in vista del vivere bene».
Noi non vogliamo (soprav)vivere, accontentandoci di strappare sofferti spazi di libertà, né galleggiare in un confuso presente in attesa di un incerto futuro.
Noi vogliamo che in Europa «si viva bene», per dirla con Aristotele: obiettivo possibile solo se la persona umana, col suo irriducibile valore, con i suoi inalienabili diritti, è fine e metro di ogni azione politica. E se lo Stato nazionale è l’irrinunciabile luogo della (ri)composizione del conflitto, all’Europa va riconsegnato il senso di una comunità cooperante e vigile, accomunata da un destino comune. Questa è la casa che vogliamo abitare. Questa è la nostra idea di Europa.
In questa prospettiva, è di grande auspicio che, nelle diverse sedi della cooperazione interparlamentare, sia stato avviato un dibattito sulle modalità e sugli strumenti per rafforzare e promuovere i principi democratici e i sistemi parlamentari nell’Unione europea, anche tenendo conto delle minacce provenienti dai Paesi terzi, suscettibili di interferire nei processi democratici nell’Unione europea, inclusi i rischi di disinformazione.
Estremamente positiva è l’iniziativa promossa dal Vicepresidente del Parlamento europeo, Othmar Karas, in occasione di un incontro con i funzionari rappresentanti dei Parlamenti nazionali a Bruxelles, nel febbraio 2022, con l’obiettivo di redigere una Carta del parlamentarismo in Europa.
Con particolare riferimento alle cosiddette «minacce ibride», esiziali per la nostra democrazia, l’imminente scadenza elettorale del 2024 impone la massima attenzione, anche in ragione dell’importanza che le elezioni del Parlamento europeo rivestono per la definizione dei nuovi equilibri politici all’interno dell’Unione, soprattutto in vista della formazione della nuova Commissione.
D’altra parte, altissimi sono i pericoli associati alla manipolazione delle informazioni, tanto più se realizzata con gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale.
In questo contesto, sarà interessante conoscere al più presto l’annunciato pacchetto legislativo per la difesa della democrazia, che dovrebbe contenere un articolato spettro di misure indirizzate a contrastare la disinformazione e gli attacchi informatici tesi a manipolare i processi democratici, soprattutto nella fase più sensibile, quella elettorale.
Non solo. Sono state annunciate misure orientate ad assicurare maggiore trasparenza nella rappresentanza di interessi, con particolare riguardo ai contatti tra lobbies e membri del Parlamento, nonché a monitorare i possibili finanziamenti provenienti da Paesi terzi, intercettando con efficacia comportamenti illegali e fenomeni di corruzione. I fatti che hanno coinvolto alcuni membri del Parlamento europeo, al di là degli esiti delle singole vicende giudiziarie, ci restituiscono un quadro opaco e ambiguo che alimenta la sfiducia e il distacco dei cittadini. Occorre la massima severità nel sanzionare severamente questi episodi e nel prevenire, in futuro, condotte così riprovevoli.
Nella più generale prospettiva di un rinnovamento coraggioso dell’architettura istituzionale dell’Unione europea, è necessario dare seguito ai lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa.
Purtroppo, gli esiti della Conferenza, per la cui nascita mi ero speso moltissimo in sede di Consiglio europeo, sono stati poco coraggiosi. Il conflitto in Ucraina e la crisi energetica hanno imposto una riconsiderazione delle priorità e, conseguentemente, hanno sottratto spazio e centralità a un’iniziativa che nasceva con ben altre ambizioni.
Il lavoro svolto è stato comunque di assoluto rilievo e le numerose proposte, contenute nella Relazione finale, colgono bene le traiettorie lungo le quali dovranno indirizzarsi le politiche europee dei prossimi anni: cambiamento climatico e ambiente, salute, giustizia sociale e occupazione, ruolo dell’Unione europea nel mondo, Stato di diritto, sicurezza, trasformazione digitale, rafforzamento della democrazia, migrazione, cultura, giovani.
Tutto questo dovrà inevitabilmente tradursi in progetti concreti, dopo aver individuato le priorità sulle quali concentrare il lavoro. Al riguardo, condivido la proposta, avanzata dal presidente Macron in occasione dell’evento conclusivo della Conferenza, di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati. Di fronte alle nuove sfide che attendono l’Europa, è maturo un momento costituente, che si inveri in un percorso riformatore ampio e ambizioso, suscettibile anche di proiettare l’Europa nel consesso internazionale come interlocutore autorevole e credibile, capace di incidere sugli equilibri geopolitici globali, tanto più in una congiuntura storica segnata dall’insicurezza e dall’emergere prepotente di antichi e nuovi conflitti.
Innanzitutto, occorre semplificare i processi decisionali, attraverso un maggiore ricorso alla maggioranza qualificata, ampliando le materie su cui è possibile superare il vincolo dell’unanimità, tanto più in vista di ulteriori allargamenti.
È vero che questo obiettivo, grazie allo strumento della cosiddetta «clausola passerella», è raggiungibile anche senza modificare i Trattati. Tuttavia, un intervento al livello «costituzionale» (se è consentito ricorrere a questa espressione in tale contesto), avrebbe il merito di ordinare, in modo chiaro e sistematico, l’intero quadro delle competenze e delle procedure.
È inoltre auspicabile agire con coraggio per rafforzare adeguatamente ruolo e poteri del Parlamento europeo, unica istituzione che gode di diretta legittimazione democratica, con particolare riguardo al potere di iniziativa legislativa e di inchiesta, ma anche con riferimento a un potere generale di accountability rispetto alle altre Istituzioni europee.
Allo stesso tempo, un adeguato rafforzamento degli istituti di democrazia diretta rappresenta, anche in chiave europea, un’evoluzione essenziale per il recupero di credibilità nei confronti dei cittadini.
Ma soprattutto, per contrastare le tendenze centrifughe e alla disintegrazione europea, figlie talvolta della disillusione europea, occorre una più chiara e rinnovata definizione degli obiettivi (neutralità climatica, crescita, occupazione, giustizia sociale, lotta alle diseguaglianze, tutela dei diritti), suscettibili di rinnovare il patto di fiducia dei cittadini e ridonare entusiasmo al progetto europeo, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni.
Le forze progressiste sono chiamate a una sfida decisiva: contrastare i ripiegamenti identitari e la asfittica chiusura all’interno del perimetro dell’«interesse nazionale», respingere il vento nazionalista che soffia sul Continente. Il modo migliore per vincere questa sfida è lavorare, con lungimirante concretezza, per rafforzare la credibilità e l’affidabilità della comune casa europea, abbracciando, con coraggio e fiducia, una prospettiva di rinascita, di conversione verso un modello di sviluppo più equo, più solidale, più attento all’ambiente, orientato al pieno e integrale sviluppo della persona e fondato su nuove relazioni tra uomo e mondo, tra etica e tecnologia, tra ambiente e sviluppo.
È una sfida da cogliere con entusiasmo e generosità, una grande sfida per la nuova Europa.
(Precedentemente pubblicato su Il Grand Continent)