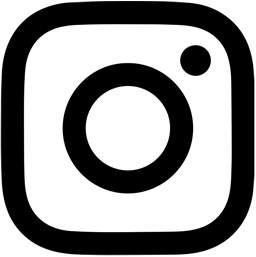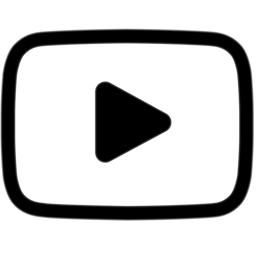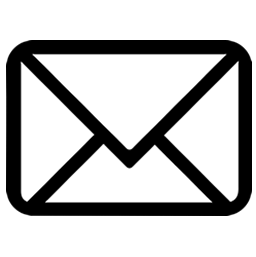di Isaac J.P. Barrow
La sovranità digitale è ormai un nodo politico, economico e culturale di prima grandezza. Significa domandarsi chi controlla realmente le infrastrutture digitali, chi decide le regole dell’accesso ai dati, chi stabilisce gli standard tecnologici e chi esercita il potere in un mondo in cui la vita quotidiana dipende sempre più dal digitale, significa democrazia.
Fino a pochi anni fa la questione si riduceva al possesso materiale, server, cavi sottomarini, hub di connessione. Oggi il discorso è molto più complesso, la sovranità digitale riguarda l’hardware, il software, gli algoritmi, la proprietà e la gestione dei dati. In altre parole riguarda chi ha il potere di scrivere le regole che strutturano la nostra vita digitale.
Un editoriale del The Guardian ha raccontato una vicenda emblematica in Australia. Scott Farquhar, cofondatore di Atlassian e presidente del Tech Council of Australia, ha presentato al governo un piano che prometteva benefici economici per circa 115 miliardi di dollari l’anno, pari a 4300 dollari a persona. In cambio però le grandi aziende tecnologiche chiedevano tre concessioni decisive: un’esenzione dalle leggi sul copyright per poter estrarre e utilizzare liberamente i contenuti con il text e data mining; l’approvazione rapida di nuovi data centre, con impatti enormi su energia e acqua e una legge che prevedeva che le aziende straniere potessero utilizzare queste infrastrutture senza sottostare pienamente alle leggi locali. L’articolo denunciava quindi il rischio di un baratto che mette in gioco cultura, risorse e democrazia in cambio di promesse economiche difficili da verificare.
Questo fenomeno è ancora più evidente con la crescita esponenziale dei data centre necessari a supportare intelligenza artificiale e servizi digitali. La loro costruzione implica un enorme consumo di energia e di acqua. In Australia alcuni progetti sono stati approvati senza un piano chiaro di gestione delle risorse idriche, nonostante il consumo stimato equivalga a quasi il 2% dell’intero fabbisogno di Sydney.
In Europa il dibattito è altrettanto acceso. In un articolo su The Economist l’ex amministratore delegato di SAP, Christian Klein, ha criticato duramente l’approccio europeo alla sovranità digitale, definendolo malgestito. Secondo il manager l’Unione Europea si concentra troppo sull’infrastruttura fisica, data centre, server, cavi, e troppo poco su ciò che realmente determina il potere nel digitale, il software, gli standard e l’interoperabilità. Il rischio è evidente. L’Europa potrebbe illudersi di essere autonoma perché possiede server e strutture sul proprio territorio, ma in realtà restare dipendente da software e protocolli sviluppati altrove, su cui non ha alcun controllo. È un paradosso, investire miliardi in infrastrutture senza conquistare la capacità di stabilire regole e standard.
Un altro articolo dell’Economist ha parlato della nascita dello splinternet, un internet sempre meno globale e sempre più frammentato. Ogni Stato cerca di imporre le proprie regole creando barriere legali e tecnologiche. Ne risulta un mosaico di territori digitali separati, spesso governati più da aziende private che da istituzioni pubbliche.
Questo scenario mina l’idea originaria della rete come spazio libero, universale e aperto. Al posto di un’infrastruttura comune al servizio della conoscenza e della cooperazione rischiamo di trovarci in un arcipelago di isole digitali ognuna governata da logiche nazionalistiche o da oligopoli tecnologici. La questione riguarda direttamente la politica e la democrazia. Il potere dei colossi digitali si intreccia con quello dei governi in un gioco fatto di scontri, compromessi e subordinazioni reciproche.
L’esempio di Mark Zuckerberg è emblematico. Prima delle elezioni del 2016 Facebook fu accusato di non aver contrastato la diffusione di fake news e campagne di disinformazione. Dopo la vittoria di Donald Trump il fondatore di Facebook adottò un atteggiamento molto più conciliante, quasi subordinato, nei confronti della Casa Bianca. In pochi mesi si passò da posizioni difensive a un abbassare la testa di fronte al nuovo presidente per proteggere interessi aziendali e relazioni politiche. Ed è emblematico l’atteggiamento disteso e deferente con cui, due settimane fa, Zuckerberg si è presentato alla Casa Bianca insieme a Tim Cook e ad altri leader delle big tech per una cena con Trump, apparendo con il capo chino davanti al potere politico (ecco il video) mentre prometteva investimenti per almeno 600 miliardi di dollari entro il 2028 negli Stati Uniti, soprattutto in data centre e infrastrutture digitali.
Questo caso dimostra due aspetti centrali. Le piattaforme digitali hanno una responsabilità enorme sul funzionamento della democrazia. Anche giganti come Facebook, pur avendo potere economico e tecnologico senza precedenti, finiscono per piegarsi al potere politico quando conviene ai propri interessi. È un intreccio pericoloso perché non è mai chiaro chi comandi davvero, se lo Stato o le corporation. Le conseguenze di questa dinamica sono molteplici. La dipendenza infrastrutturale, la perdita di controllo normativo, la manipolazione dell’informazione, la possibilità che interi settori culturali vengano subordinati agli interessi di poche aziende. Se i governi lasciano che siano i privati a scrivere le regole del digitale rischiano di trasformarsi in amministratori secondari incapaci di proteggere la democrazia e i diritti dei cittadini.
Le soluzioni esistono e molte di esse sono già state proposte anche su questo blog. In un post intitolato Non con i dazi ma con i dati, Beppe ha sottolineato come la vera ricchezza del futuro siano i nostri dati personali. Riprenderci i nostri dati significa riconoscere che ciò che produciamo ogni giorno, ricerche, like, spostamenti, abitudini di consumo, è il vero capitale che alimenta i Big Tech. Restituire ai cittadini il controllo di questi dati è il primo passo per riequilibrare il rapporto di potere.
Un’altra proposta, Un aggregatore per i nostri dati personali, immaginava la creazione di strumenti collettivi, veri e propri aggregatori, in grado di raccogliere e gestire i dati in maniera trasparente e condivisa. In questo modo non sarebbero più dispersi nelle mani di multinazionali ma gestiti come bene comune, con regole chiare e garanzie per i cittadini.
Costruire data centre non basta, bisogna sviluppare codice, infrastrutture digitali aperte e soprattutto un’etica che rimetta al centro la democrazia e non il profitto. I nostri dati rischiano di diventare la moneta con cui cediamo libertà in cambio di servizi gratuiti. Il futuro delle democrazie passa anche dal modo in cui difendiamo il nostro spazio digitale. Se la sovranità appartiene al popolo deve valere anche nel mondo dei dati.
L’AUTORE
 Isaac J.P. Barrow – Professore sociologo specializzato in dinamiche sociali globali. Tutta la sua carriera si è concentrata su globalizzazione e tecnologie digitali. Ha svolto ricerche in vari paesi ed è autore di studi su identità culturali e disuguaglianze. Ha collaborato con organizzazioni internazionali ed è considerato un esperto di politiche sociali ed inclusione.
Isaac J.P. Barrow – Professore sociologo specializzato in dinamiche sociali globali. Tutta la sua carriera si è concentrata su globalizzazione e tecnologie digitali. Ha svolto ricerche in vari paesi ed è autore di studi su identità culturali e disuguaglianze. Ha collaborato con organizzazioni internazionali ed è considerato un esperto di politiche sociali ed inclusione.