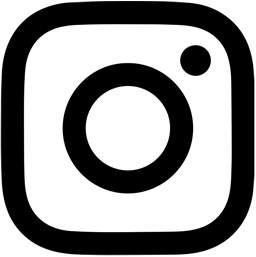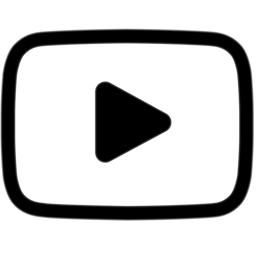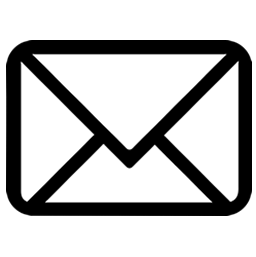di J. Lo Zippe
Siamo il Paese dove si fa ancora il miglior caffè, ma la moka si produce in Cina. Dove si disegna moda che fa il giro del mondo, ma gli abiti si cuciono nei capannoni del Vietnam. Dove i distretti industriali una volta trainavano l’economia, oggi chiudono in silenzio mentre i marchi volano via. Negli ultimi mesi, un numero crescente di aziende italiane ha fatto le valigie: chi va in Serbia, chi in India, chi in Tunisia. Alcuni lo dicono, altri lo fanno e basta. Le ragioni? Sempre le stesse: costi più bassi, meno regole, incentivi a pioggia. A pagare, come sempre, sono i lavoratori. E l’Italia che resta indietro.
Si tratta di una dinamica che riguarda tutti i settori: l’automotive, il tessile, l’abbigliamento, l’elettrodomestico, la componentistica, persino i beni simbolici del Made in Italy. Da tempo, imprese di piccole e grandi dimensioni trasferiscono attività in paesi dove la manodopera costa meno, le regole sono più leggere e i governi offrono incentivi generosi. Il risultato, altrettanto chiaro: meno lavoro in Italia, meno fabbriche, meno prospettive.
Fiat, oggi parte del gruppo Stellantis, ha ridotto drasticamente la produzione in Italia. Nel 2024 sono stati prodotti 475.000 veicoli, quasi il 40% in meno rispetto all’anno precedente. È il dato più basso dagli anni Cinquanta. In parallelo, gli stabilimenti in Polonia e Serbia sono diventati i nuovi poli di riferimento. Dainese ha spostato quasi tutta la produzione in Tunisia, mantenendo in Italia poco più di un centinaio di figure tra controllo qualità e management. Geox realizza le sue calzature tra Cina, Vietnam e Brasile: su circa 30.000 dipendenti, meno di 2.000 si trovano oggi in Italia. Bialetti ha chiuso lo stabilimento di Omegna e trasferito la produzione delle storiche moka in Cina. Omsa ha fatto lo stesso, portando in Serbia il cuore produttivo e lasciando a casa oltre 300 lavoratrici. Rossignol ha scelto la Romania. Ducati Energia si è orientata verso India e Croazia. E poi Benetton, Calzedonia, Stefanel: quasi tutte con produzioni ormai radicate nell’Est Europa o in Asia. Benetton, in particolare, ha avviato un piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di 500 negozi a livello globale, di cui circa 200 in Italia. Calzedonia possiede stabilimenti propri in Bulgaria, Romania, Croazia e Sri Lanka. Stefanel ha esternalizzato quasi del tutto la produzione, riducendo drasticamente la presenza manifatturiera in Italia. Si parla spesso di efficienza, ma il prezzo lo pagano sempre gli stessi.
Dietro ognuna di queste scelte ci sono ragioni economiche evidenti: abbattere i costi, sfuggire a una burocrazia asfissiante, cercare manodopera più flessibile. Ma c’è anche un prezzo sociale che raramente finisce nei bilanci. Ogni fabbrica che chiude lascia dietro di sé posti di lavoro persi, competenze abbandonate, territori impoveriti. In questi mesi le proteste dei lavoratori si sono fatte sentire: scioperi, presìdi, lettere aperte. Le risposte, però, spesso non arrivano.
Il tessuto produttivo italiano continua a cambiare pelle. L’occupazione nell’industria è in calo, soprattutto tra i lavoratori over 50. I distretti storici perdono pezzi. Le competenze tecniche si disperdono. Chi riesce a ricollocarsi cambia settore, spesso accettando lavori meno qualificati e meno retribuiti. Chi non ci riesce, esce dal mercato. Nel frattempo si parla di reshoring, il ritorno in patria di alcune produzioni, ma si tratta ancora di episodi isolati, legati più alla crisi logistica globale che a una scelta strategica. Il rischio è chiaro: un’Italia con pochi poli produttivi ad alta automazione, dove lavorano tecnici specializzati, e un’ampia fascia di territorio consegnata a mansioni precarie, alla logistica just-in-time e ai servizi a basso valore aggiunto. Un modello che non tiene, né sul piano economico, né su quello sociale.
Chiudono stabilimenti, si spostano linee produttive, si perdono competenze, ma tutto avviene con una certa disinvoltura, come se fosse normale. E in fondo lo è diventato. Le delocalizzazioni oggi non fanno nemmeno più notizia: non si licenzia, si “ristruttura”; non si chiude, si “ottimizza”; non si scappa, si “internazionalizza”. E intanto ci ritroviamo con sempre meno fabbriche, sempre più centri commerciali, e giovani costretti a scegliere tra fare i rider o fare le valigie. Chi resta, guarda i capannoni vuoti e si chiede se davvero dovevamo finire così: a esportare il lavoro e importare precarietà.
E mentre le grandi aziende delocalizzano, ci sono anche storie più piccole ma non meno amare. Come quella di due ragazzi che sei anni fa hanno aperto una libreria nel cuore di Napoli. Contro ogni previsione, con coraggio, entusiasmo e l’idea che restare avesse un senso. Oggi quella libreria chiude. Non per mancanza di idee, ma per mancanza di ossigeno. La loro storia non è un’eccezione: è la stessa Italia che si svuota, un pezzo alla volta.