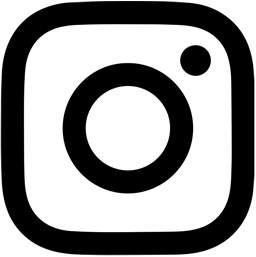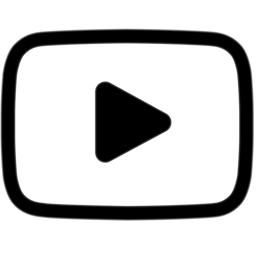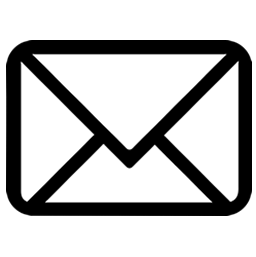E allora oggi è un giorno di fine luglio, bituminoso e accecante, e sono seduto in un fast food bio affollatissimo, presso l’autogrill più stremante e vasto dell’intera A1. Per arrivare qui, a conquistarmi una sedia in propilene rossa e una porzione di tavolo a effetto legno, dove posare l’emulazione fallita di una carbonara, ho visto cose che voi umani avete tutti visto insieme a me. Ho scrutato cardiopatici maneggiare con rispetto sacrale le lezioni di inglese istantaneo di Peter Sloan, una riedizione contemporanea e linguistica di Don Lurio. Ho oltrepassato i corpi inerti di pensionate seborroiche che tentavano di arieggiarsi con ventilatori USB non infilati in nessuna porta USB. Ho circumnavigato intorno a un presunto camionista, presuntamente polacco, che si ripuliva le mani con acqua ossigenata, dopo avere assimilato un Rustico. Ho contemplato ludopati ultracinquantenni sfregare in serie con monetine la palta grigiastra da grattare per perdere al Miliardiario o al Turista Per Sempre. Ho aiutato l’amministratrice delegata di una compagnia telefonica a infilare un cicciolo fritto tra i denti del suo yorkshire distrofico (nessuna donna siede ai vertici delle telefoniche; il cagnolino non era affatto distrofico, stava solo congelando sotto una tubatura che eiettava una corrente catabatica antartica). Ho penetrato un gruppo di maestri assaggiatori di cioccolato, che soppesavano veganamente i grassi polinsaturi di muffin al cacao. Ho incrociato un nucleo famigliare che era una famiglia nucleare, nel senso di un’esposizione diretta a un’esplosione nucleare, il padre in epidermide cuoiata, la madre anafilattica, tre bambini fatti della stessa sostanza dei marshmallow, tutti ad aspettare con sguardo assente che si decongelasse un pollo nella borsa termica aperta. Ho lambito completi in acrilico puntinato e canotte maschili prese su Zalando, infradito Marbella verde scintigrafia e una fascia elastica ortopedica addominale color rosa carne, short dress in poliestere per taglie forti e anagrafi avanzate, un completo da tennista striato di terra rossa. Ne ho viste di cose, io – e loro hanno visto me. Il popolo dell’autogrill, se ancora è un popolo, mi ha intercettato mentre lanciavo il pancreas oltre l’ostacolo e mi aggiudicavo una carbonara fluorescente, catapultandomi con il vassoio oltre le casse? Pare di sì.
Il binomio carbonara e Autosole non è inedito. L’autostrada del Sole, per i miei coetanei, cioè gente che ha più di mezzo secolo italiano sulle spalle, è stata plasticamente rappresentata in una hit tedesca e dimenticata, del 1982, che faceva così: “Io voglio viaggiare in Italia, in paese dei limoni, Brigade Rosse e la Mafia cacciàno sulla Strada del Sol”. La canzonetta si intitolava appunto “Carbonara”. Le Brigate Rosse si sono volatilizzate nel sanguinoso pulviscolo della storia, la mafia si è sussunta a un livello algoritmico e finanziario inquietante. E’ rimasta la carbonara, insieme all’autostrada. E alle aree di sosta, che milioni di italiani per un cinquantennio hanno atteso caracollando sulle corsie, trattenendo le vesciche e pensando al panino Camogli o ai suoi predecessori (il Camogli fu lanciato nell’anno in cui gli Spiff composero “Carbonara”).
L’Italia è come sempre un’entità spirituale che fa dell’orrore un sintomo di angosciosa bellezza. E’ la patria degli autogrill. Nacquero negli Usa, spopolarono da noi. Il primo fu inaugurato nel 1959, da un quarantenne azzimato con qualche problema di mandibola e di cattolicesimo: era l’allora sottosegretario agli Interni, Oscar Luigi Scalfaro. Passa mezzo secolo e il suo principale avversario politico, ossia Silvio Berlusconi, si fa immortalare in autogrill (ognuno ha l’immortalità che merita), mentre soppesa una noce di prosciutto al pepe, specchiandosi fedelmente nel salume più incongruente dell’intera vicenda suina.
La storia d’Italia potrebbe essere letta attraverso le installazioni, da Bauhaus impazzito, di questi palindromi architettonici, uno a est e l’altro a ovest delle grandi arterie. Durante i primi seimila anni del mondo, dalla pagoda più immemorabile dell’Indostan fino alla cattedrale di Colonia, l’architettura è stata la grande scrittura del genere umano. Victor Hugo sosteneva che il libro avrebbe ucciso l’edificio, ma nel caso dell’autogrill è accaduto il contrario, nonostante vi si vendano a palate i titoli più imbarazzanti del mainstream editoriale. In Italia l’ambiente in cui le genti si riconoscono spontaneamente è un luogo sempre identico, che muta nome a seconda delle coordinate e si chiama Somaglia, San Zenone, Cantagallo, Teano, Roncobilaccio, Ronco Scrivia, La Macchia Est – località astratte, coincidenti con le pause di viaggio e le esperienze oniriche collettive in autogrill.
Si ride da tempo di questo nonluogo che ha creato un immaginario collettivo, ageografico ma agiografico, euforizzante nel momento in cui si è stanchi o ti sta per venire una calcolosi renale. L’imposizione dei bisogni superflui, in forma di opera omnia di Eros Ramazzotti o di tubo da due chili di Pringles, ha maturato perversioni indicative dello stato culturale di questo Paese. L’area di sosta è un altare della patria, un anonimato celebrato con ciclica continuità. Si pensava che fosse una cosa divertente che non farò mai più, mentre si trattava una cosa per niente divertente che non si smetteva di fare. Sai le risate? Arbasino era ridanciano nella descrizione di questo spazio templare e laico, ispirando Tognazzi che illustrava al figlio etologia e semiotica dei polli d’allevamento. Benni pure, col suo autogrill horror. Guccini anche, con il suo canto antimelodico sulla commessa dietro il bancone. E ugualmente Labranca, il geniale inventore del trash all’italiana, che fenomenologizzava la noce di prosciutto al pepe come arco voltaico tra Martin Heidegger e il brianzolo che è in tutti noi. Per decenni la fantasmagoria della proprietà e della merce è stato un idolo della tribù italica, come l’utilitaria Fiat, come le vacanze, come la foto collettiva con i grembiulini a scuola. Ci si riconosceva nelle produzioni artefatte di quell’esposizione universale e ributtantemente esotica, che era e rimane l’autogrill. E’ la comfort zone, qualcosa di continuamente stabile mentre ci si sposta, il ritorno del sempreuguale prima del casello o dello svincolo. Nietzsche in fusione fredda con il Praga. Ben più che nei monumenti italiani, ci si riconosceva nella misteriosa pasta tricolore che li celebra. A questo riconoscimento si reagiva con un calore da combustibile chimico: riconoscersi significava interpretarsi in una connessione più vasta e condivisa, cioè italiana. Poi è cambiato qualcosa: è cambiata l’Italia.
Non fa più ridere l’Italia. C’è poco da divertirsi con la materia nazionale, intrisa di crudeltà spiccia, rorida di sangue mediterraneo (il mare), abbruttita nel delirio da autodifesa armata, consumatrice di psicofarmaci in numero di 34 milioni di confezioni l’anno, afflitta da ciclopiche percentuali di disturbo dell’apprendimento, con tassi di desanitarizzazione incipiente, 21 milioni di cittadini soggetti a contenzioso con il fisco, cento famiglie al giorno che subiscono uno sfratto, il record di un quarto dei giovani connazionali che non studiano né lavorano né il lavoro lo cercano. Nell’ultimo quinquennio l’Italia è diventata un laboratorio sociale regressivo, un’associazione per delinquere di stampo morale, un hellzapoppin dell’obbrobrio e dell’abbandono. Il grande immaginario collettivo non esiste più, dilacerato dal crollo dell’empatia e dall’enfasi del futuro zero. Il tempo della comune risata davanti al grottesco che siamo tutti sta finendo oggi, anzitutto in autogrill – questa apoplessia della nazione, questo teatro naturale dell’Oklahama italiano, questo giunto cardanico che coniuga paese reale e vendita al dettaglio.
I dettagli, appunto, sono importanti. Per esempio: hanno spostato la noce di prosciutto al pepe. Non in tutti gli autogrill: in qualcuno. Me ne sono accorto dallo spaesamento che i più manifestavano alla svolta del minimarket, dove sono stipati i prodotti ipoteticamente territoriali: strani culatelli bilaterali di zibello, Sua Squisitezza il felino, il regno fantastico di Provolandia, la militarizzazione del Sangiovese, le materie prime del Gran Casato dei Sapori. Lì, da sempre, ipocritamente terragna, costipata con granulomi di pepe che staffilano l’olfatto, meteoritica nella superficie e noumenica nel cuore crudo, che si cela all’interno della barriera asteroidale di spezie piccanti, in un cesto di vimini che ne esibisce la fantasiosa rusticità, metasalume che sintetizza qualunque peculiarità gastronomica, dal canederlo alla ’nduja, giace, interrogativa e cultuale, la noce di prosciutto al pepe. Essa pulsa. Non riusciamo a non palparla, ammorbidendo i nostri sudori con il pastoso sfregamento contro i suoi grani oleosi. Servirebbe la lisciva, per ripulirsi l’epidermide di quell’untume speziato. Tocchi la noce di prosciutto al pepe e diventi tu stesso una noce di prosciutto al pepe. Traspira, dà l’impressione del vivente allo zombie autostradale che la saggia, ignaro da sempre e per sempre del gusto di quelle carni. Chiunque nel suo foro interiore si è chiesto che sapore abbia, chi si sia azzardato a comprarla, chi si sia spinto addirittura a consumarla e perché sia in vendita soltanto qui, in autogrill. Oggetto proletario del desiderio che non si sa di desiderare, canto delle sirene di terra, questa radicale antagonista dell’ittico passa di mano in mano da generazioni, testimonianza che il fil rouge che fa l’Italia è rosso speck. Il salumaio a capo della nazione è un sogno nostrano, puntualmente avveratosi. In qualche modo il Parmacotto e il Rovagnati qui hanno governato. Prodotto tipico di nessuna tipicità, incarnazione di un principio suino e trascendente, la noce di prosciutto al pepe ostenta una natura sacerdotale, qualcosa di affine al Corpus Domini, l’emblema di un messianismo insaccato, una particola donata ai molti figli dell’uomo dal Figlio della Scrofa. Faceva, fa ridere. E’ pietra miliare che misura la nostra vicinanza agli altri e la distanza dall’uscita del supermercatino. Un organismo alieno, come se le navi di “Arrival” contenessero abnormi mortadelle senzienti.
Sfiancati dai chilometri, immersi nella comune marginalità delle nostre esistenze, distanti pochi metri dal flusso di auto a guidatore ancora umano, tutti bipedi e simmetrici e poveracci a partire da me, siamo incantati dalla conclamata assenza della noce pepata. Ci si chiede se per caso sia fallito il salumificio Nino Galli, monopolista del celebre salume, che nel Verbano Cusio Ossola detiene la formula segreta di questa prelibatezza. Lo sconcerto è tanto. Un sentimento di orfanità coglie chiunque. Li osservo, uno per uno, stupefatti alla svolta: sostano qualche secondo, lo sguardo svuotato per un’astrazione di sé, per una dissociazione momentanea. Gli esoftalmi rientrano. I volti si marmorizzano. Un’armata fantasma e senza nome paga il suo tributo all’assunzione del prosciutto nei cieli.
Sono, siamo: sciatti, sfiniti, incomunicanti. A differenza del passato, coglie la comunità dell’autogrill una sdrucitezza di nuovo tipo, un movimento casuale dentro percorsi preordinati, in cui vagolano atomi umani in libertà controllata. Si gira e si consuma, senza parlare agli altri consumatori, neanche accidentalmente. Si ciabatta verso i bagni inferiori, dove l’urea stempera nella tenuità dei legni e della luce alogena. Si rimane un po’ inebetiti, a cercare di comprendere come funziona lo sciacquone con la fotocellula. Si risale, si afferra male un vassoio, la carta plasticata si mette di traverso, si bascula vagamente storditi di fronte a insalate di farro e macedonie preconfezionate. Pare di muoversi in spazi che vanno a rudere: in qualche modo la nostra contemporaneità produce ancora rovine. La proprietà degli autogrill investe in bioarchitetture, in geotermia, in fotovoltaico – ma nulla salva dal sentimento di indistinta decadenza. Il fatto è che non c’è più rito collettivo: non c’è ritualità e non c’è collettività. Si toccano corpi in abulia, più che nel passato. Tutti singoli e separati da un mutismo selettivo e abnorme.
“Siamo lobbisti. Armi. Andiamo a una convention. Si parla, si incontrano persone interessanti. Si gioca a golf”.
L’avevo intuito che lì si gioca a golf. Ciò che non avevo intuito è che questi maschi muflonici possono cambiare l’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa.
“Salvini? Una brava persona. Che ha a cuore gli italiani e la sicurezza a casa propria. Il resto è buonismo”. L’animal master dei golfisti armigeri mima uno swing in piena area parcheggio, scruta l’inesistente parabola della pallina fantasma, si deforma in un sorriso triglicerico. Si volta verso di me come se io fossi un caddie cingalese. Provo una lirica commozione verso i suoi lineamenti altolombardi. Mi dice: “E’ cambiata l’aria”.
Non quella condizionata. All’interno è un’escalation verso vette polari inusitate. Rivedo il maschio alfagolfista, silenziosamente affranto per la scomparsa della noce pepata. Il silenzio per nulla religioso, che è anzi il contrario di ogni religione, deforma i volti di chiunque realizzi la scomparsa del mitologico alimento. Sono tutti vaghi sosia di qualcun altro, tranne il ritratto vivente di Guido Barilla, con quei capelli lì, vestito come veste sempre Guido Barilla, abbigliato più Facis che Guido Barilla. Io del resto sono il vago sosia dell’attore Flavio Bucci. Non si deve scordare per un secondo ciò che i due terzi dei vaghi sosia (li ho contati) non hanno cessato un attimo di dire, prima della svolta al minimarket, e che diranno un passo dopo: i negri, gli sbarchi, i vaccini, gli antibiotici, la legittima difesa, i reati, la crisi, i politici, la destra uguale alla sinistra. In qualunque luogo, di massa o meno, due terzi dei presenti vuole ridurre gli arrivi, uno su tre vuole una pistola in casa, uno su cinque assume psicofarmaci, un giovane su tre è disoccupato. Le radici reali di una decadenza ad alta intensità.
La noce di prosciutto al pepe era stata semplicemente dislocata qualche metro più avanti. La resistenza italiana è una renitenza. Ogni simbolo viene abolito infinitamente: non cessa di finire. E’ il sale della vita e il pepe del prosciutto.
Afferro una noce speziata con la mano sinistra, percepisco la consistenza scabra e irregolare della superficie, è lugubre come tutto qui. E’ grande quanto il cranio di un bambino, la interrogo con lo sguardo mentre la reggo con mossa plastica nell’aria e pronuncio la domanda italiana più radicale e frantumante: “Essere o non essere?”. Come sempre, so cosa scegliere e l’Italia con me.
[di Giuseppe Genna, l’Espresso, 7 agosto 2018]