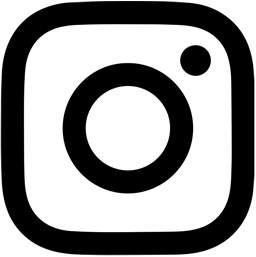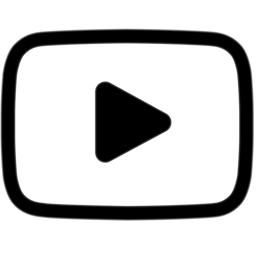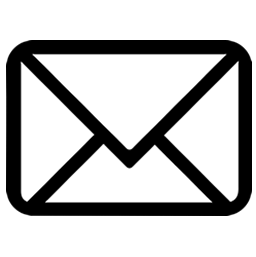Le epidemie che minacciano l’uomo arrivano soprattutto dalle foreste. David Quammen ha seguito gli scienziati che cercano gli animali «untori». E li racconta in un libro. (Spillover, edito da Adelphi)
L’umanità sta giocando alla roulette russa con i virus. Ogni volta che tagliamo foreste, ammassiamo animali negli allevamenti e nei mercati, mangiamo specie selvatiche o le costringiamo a convivere con noi, corriamo il rischio di far partire un proiettile virale. Qualcuno ci ha già colpito e ci ha fatto male (Aids, Ebola e Sars, per esempio), ma continuiamo a premere il grilletto.
A limitare i danni di questa nostra sconsiderata noncuranza è, per fortuna, un pugno di scienziati coraggiosi, i «cacciatori di virus».
Di loro, e dell’attualissimo tema di come si originino le epidemie, tratta il libro Spillover del giornalista scientifico freelance David Quammen.
Spillover è il termine con cui i microbiologi indicano il passaggio di un patogeno da una specie all’altra. Quando il punto d’arrivo è l’uomo siamo in presenza di una «zoonosi » e, in genere, sono guai grossi, perché il microorganismo è nuovo al nostro sistema immunitario e perciò può rivelarsi altamente letale: è, appunto, il caso di Ebola, Aids, influenze aviarie e Sars. A evitare una catastrofe spesso è solo il fatto che il patogeno passa con difficoltà fra uomo e uomo. E almeno in un caso, quello della Sars, a salvarci da un disastro planetario sembra sia stata soprattutto la fortuna.
Quammen, 66 anni, collabora con il National Geographic, Harper’s Bazaar, Rolling Stone e New York Times, e per scrivere i suoi dieci saggi su natura ed evoluzione ha girato il mondo, avvicinandosi il più possibile agli oggetti del suo interesse e ai ricercatori che li studiavano. L’idea per Spillover gli venne quando, nel 2000, trovò tredici gorilla uccisi da Ebola nella foresta del Congo. Impressionato da quella strage, Quammen da allora segue i cacciatori di virus nelle loro ricerche.
«Sono persone come Beatrice Hahn, microbiologa dell’Università della Pennsylvania, che ha raccolto e analizzato il sangue di centinaia di macachi e scimpanzé selvaggi africani per ricostruire il punto di origine dell’Aids. O Eric Leroy, veterinario francese, che nel 2006 cercò Ebola in più di mille animali diversi fra Congo e Camerun, trovandolo, alla fine, nel pipistrello della frutta. Alcuni li ho seguiti sul campo, come Aleksei Chmura, ricercatore dell’organizzazione americana non profit EcoHealth Alliance: per capire da dove arrivasse la Sars, mi ha portato a catturare pipistrelli nelle grotte della Cina meridionale: lì abbiamo strisciato in cunicoli coperti di guano, rischiando di essere morsi o graffiati da animali infetti con quel virus mortale».
Sembra che il compito principale di questi Indiana Jones della microbiologia sia quello di individuare il «serbatoio animale » del patogeno, cioè la specie in cui il virus si nasconde, senza causare malattia.
«Cercare questo serbatoio è fondamentale perché, se non esiste, il virus è “intrappolato” nell’uomo, ed è possibile pensare di eliminarlo completamente. Se invece ha un ospite animale sono guai, perché le epidemie saranno destinate a ripresentarsi nel tempo, almeno fino a che non si bloccherà il passaggio fra animale e uomo. Un buon esempio di questo è il caso del virus Nipah, apparso in Malesia nel 1999. Sembrava che venisse dai maiali allevati dai cinesi locali. Sterminando i suini, lo si estirpò dalla Malesia, ma sorprendentemente Nipah riapparve nel 2004 in Bangladesh, Paese musulmano, dove di maiali non ce ne sono, facendo centinaia di vittime, con casi di trasmissione uomo-uomo. Stephen Luby, medico epidemiologo che dirigeva l’International Centre for Diarrhoeal Diseases Research di Dacca, si mise a interrogare la popolazione, scoprendo alla fine che il virus colpiva soprattutto chi beveva il succo della palma da dattero. Monitorando il raccolto della linfa si scoprì che i pipistrelli, i veri serbatoi del virus, andavano a bere dalle incisioni nella corteccia, contaminando con il Nipah la bevanda. Usando da allora delle semplici precauzioni, il numero di casi è crollato».
Nel caso di Hiv ed Ebola, lo spillover è stato
molto più cruento…
«In entrambi i casi i primi contagi in Africa si devono probabilmente alla macellazione di carne di scimpanzé infettati da quei virus. Ma le somiglianze si fermano qui. Gli Hiv sono virus che, pur essendo mortali, in alcuni ceppi quasi al cento per cento, restano nascosti nell’organismo per anni e possono quindi diffondersi lentamente, usando i contatti sessuali o sangue-sangue. Per questo, dal 1900, Hiv è passato almeno 12 volte fra scimmie ed uomo, ma non ce ne siamo mai accorti fino a che la maggiore promiscuità sessuale, l’uso di siringhe e i trasporti rapidi
non l’hanno fatto esplodere nel mondo, con 30 milioni di morti dal 1980. Ebola, apparso in Congo nel 1976, è molto diverso: è un virus “esplosivo” che stronca in pochi giorni il 50-90 per cento delle sue vittime, rendendole contagiose attraverso i fluidi emessi nella fase finale della malattia. Il fatto che Ebola sia ospitato in pipistrelli, che contagiano le scimmie o contaminano la frutta, lo rende impossibile da estirpare in Africa, ma, almeno, il tipo di contagio lo rende facile da contenere, isolando i malati».
In Liberia, Sierra Leone e Guinea, Ebola sembra però fuori controllo: ai primi di ottobre aveva colpito 7.178 persone con 3.383 morti e si sono avuti i primi casi negli Usa e in Europa.
«È la prima volta che Ebola arriva in grandi città: il successo del virus non dipende però tanto dalla sua pericolosità quanto dall’estrema povertà dei tre Paesi in cui si è diffuso. Lì la sanità è quasi inesistente, le frontiere sono permeabili e imperano ignoranza e superstizione. Anche se Ebola ha dimostrato di poter arrivare lontano attraverso i viaggi aerei, credo che Paesi con un decente sistema di risposta sanitaria non abbiano nulla da temere. È per gli africani che ci dobbiamo preoccupare».
Aids a parte, c’è stato un momento in cui abbiamo rischiato una pandemia, in questi anni?
«Il rischio più grosso l’abbiamo corso con la Sars, la polmonite provocata da un nuovo coronavirus, parente di quelli del raffreddore. Apparsa nella Cina meridionale nel 2002, dove veniva diffusa dai pipistrelli ai gatti-civetta allevati per la cucina locale, in poco tempo si è diffusa per via aerea in tutto il mondo, specialmente in Cina, a Taiwan, in Vietnam, Canada e a Singapore, con 8.100 casi e 770 morti. A salvarci è stato il fatto che la fase più contagiosa della malattia arriva quando il malato sta già molto male e non può muoversi. Per questo la Sars ha fatto strage di medici e infermieri, compreso l’eroico Carlo Urbani, il primo, ad Hanoi, a capire che si trattava di una nuova malattia e ad avvertire l’Oms. Se la Sars fosse stata contagiosa in una fase più anticipata, o fosse arrivata in un Paese con strutture sanitarie deboli, sarebbe divenuta devastante».
Ma perché i pipistrelli sono il serbatoio di
così tanti patogeni?
«Non è chiaro, ma potrebbe dipendere dal fatto che, essendo animali molto antichi e vivendo in colonie affollate, hanno evoluto la capacità di convivere con molti virus diversi. Volando, li spargono poi su vaste aree».
C’è il rischio che Ebola o altri virus letalimutino, diventando più infettivi?
«Sì. Tutte queste nuove zoonosi hanno una cosa in comune: sono causate da virus con il genoma composto da una sola catena di Rna, il più soggetto a continue mutazioni. Per questo riescono a saltare facilmente da specie a specie. Così, più tempo passano in ospiti umani più il pericolo che si adattino a noi aumenta. La letale influenza aviaria da H5N1 è arrivata a poche mutazioni di distanza dal trasmettersi fra uomo ed uomo».
Ma potrebbero anche «imparare a
convivere» con noi, diventando meno
mortali…
«Spesso va così, ma non è certo: l’unico “scopo” dei virus è aumentare la loro diffusione, non farci favori. È l’ospite che spinge il virus a mutare in un senso o nell’altro. Per esempio nel 1950 fu diffuso il virus della mixomatosi fra i conigli selvatici australiani, per diminuirne il numero. Ebbene, la mortalità, inizialmente quasi del cento per cento, nel tempo è sì diminuita, ma dopo quasi 70 anni, è ancora del 70 per cento. Con un ospite così prolifico, il virus non ha infatti bisogno di diventare “più buono”, ci saranno sempre tanti nuovi nati che sostituiscono gli uccisi».
È un’impressione, o ultimamente c’è un
gran fiorire di nuove zoonosi?
«È così, e la ragione principale sta nell’invadenza della specie umana, che occupa e distrugge zone selvagge, esponendosi così a patogeni fino a quel momento confinati nelle specie animali, sia mangiandole, sia obbligando queste specie – come i pipistrelli, ma anche i macachi, che invadono ormai molte città asiatiche – a vivere a stretto contatto con noi. Esemplare, a questo proposito, è quanto è accaduto negli Stati Uniti con la malattia di Lyme, una patologia batterica trasmessa dalle zecche. Si pensava che il suo espandersi fosse dovuto a un eccessivo numero di cervi “troppo protetti”, ma l’analisi ecologica condotta da Rick Ostfeld, ecologo del Cary Institute of Ecosystem, ha scoperto che le zecche infestano soprattutto roditori che prosperano nelle foreste frammentate dall’uomo, da cui sono spariti i loro predatori e competitori».
Articolo di Alex Saragosa, pubblicato sul Venerdì di Repubblica, il 17 Ottobre 2014